QUALE REPUBBLICA?
L’Italia nella transizione politica, istituzionale, sociale
Volume con uno scritto di Riccardo Terzi (pp. 107-137) dal titolo “Politica e anti-politica” che è una versione estesa della relazione “La transizione politica” al Convegno CGIL-IRES 1996
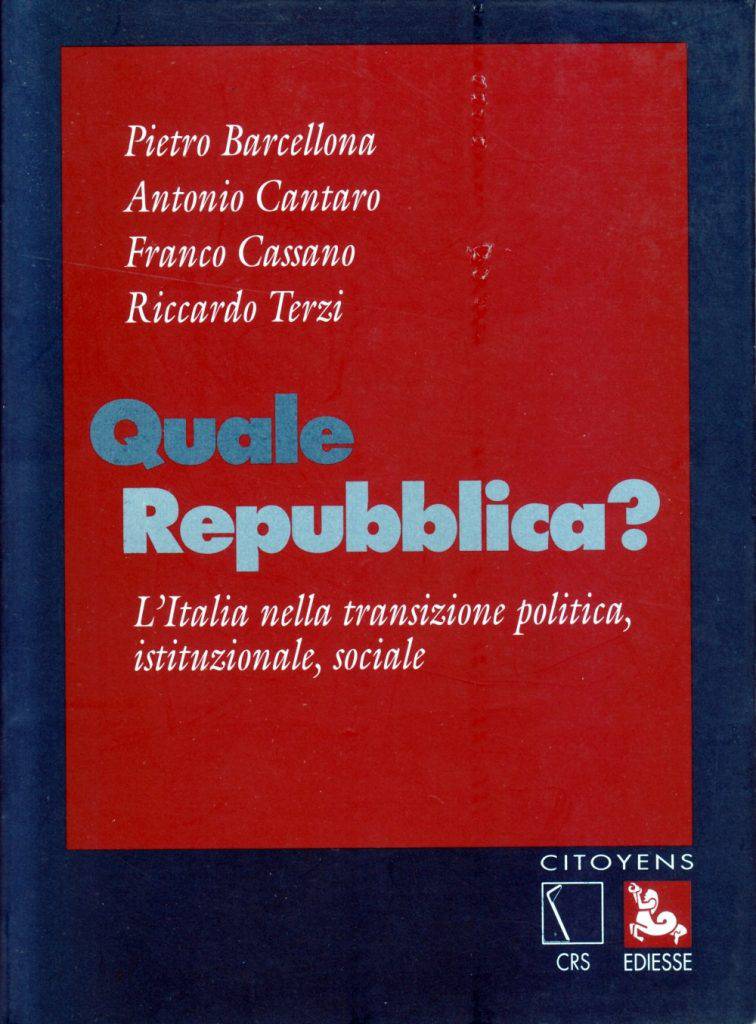 POLITICA E ANTI-POLITICA
POLITICA E ANTI-POLITICA
di Riccardo Terzi
La transizione come catastrofe
Il concetto di “transizione” è un concetto ricorrente nel linguaggio politico. La politica è infatti intelligenza del divenire e governo del cambiamento, ed è quindi sempre, in questo significato largo e generale, l’arte di navigare nella transizione.
Ma quando parliamo oggi dell’Italia nella transizione ci riferiamo, in un senso assai più stringente, ad una condizione specifica di crisi e di mutamento, la quale investe non solo l’ordinamento politico in senso stretto, ma l’intero universo di significati e di valori che ha fin qui regolato la coscienza collettiva del Paese. Lo stesso risultato delle elezioni politiche del ‘96 va letto come un momento della transizione, come un passaggio dentro la crisi.
Siamo in presenza, certamente, di un evento politico di straordinaria importanza, ma sbaglieremmo a considerarlo già come un punto di approdo, come una svolta capace di per sé di mutare l’intero scenario. La transizione sarà lunga, e siamo tuttora di fronte a molte incognite. Non funzionano più i punti di riferimento e le appartenenze tradizionali, e ancora non si sono affermati con chiarezza nuovi criteri di interpretazione del reale, nuovi valori e nuove regole di condotta. La crisi istituzionale è solo un aspetto di questa più generale instabilità e incertezza.
È una situazione aperta, non predeterminata nei suoi sbocchi, come è vero sempre nei momenti di accelerazione della crisi. Potremmo anche ricorrere all’immagine della “catastrofe”, in quanto essa designa una situazione a tal punto alterata da rendere inutilizzabili tutti gli strumenti ordinari di controllo e di regolazione. La condizione attuale ha esattamente questi connotati, in quanto si è rotto il punto di equilibrio su cui si reggeva l’intero sistema, e tutto è rimesso in discussione e in movimento.
La posta in gioco è quindi eccezionalmente alta, e non si tratta solo della posta politica -chi è legittimato dalle elezioni a governare- ma soprattutto del modello di società, dei caratteri di fondo su cui si ricostruisce l’identità nazionale. A questo fine è essenziale l’analisi dei mutamenti che sono intervenuti nella struttura produttiva e nei rapporti sociali, l’analisi cioè di quell’insieme di processi che hanno determinato il superamento e la frantumazione del modello fordista e hanno segnato un vero e proprio passaggio di fase.
Ne risulta una devastazione delle tradizionali identità di classe, una messa in crisi delle soggettività politiche che si erano costituite a partire dal conflitto, distributivo e di potere, nel luogo di produzione. Ma è anche, contestualmente, l’affermazione di nuovi bisogni di libertà, e di autonomia personale, e l’apertura quindi di nuove contraddizioni, su nuovi terreni.
La società italiana si presenta come un insieme dinamico di contraddizioni e di processi sociali tra loro divaricati e il risultato è un intreccio di fenomeni di inclusione e di esclusione, di crescita civile e di marginalizzazione. È una società esposta a nuove tensioni e a nuovi conflitti (territoriali, di generazione, di sesso, razziali), una società in bilico che stenta a trovare un nuovo equilibrio. La politica riflette questa irrequietezza, questa instabilità di fondo, ed è essa stessa il campo di movimenti non lineari, complessi, talora tortuosi.
Non c’è un’immediata visibilità dei processi politici, e sembra venir meno qualsiasi rapporto diretto tra rappresentanza sociale e rappresentanza politica. Il Paese è diviso, ma la linea di demarcazione non è una linea di classe, ma attiene piuttosto alla cultura politica, all’idea di Stato, all’etica pubblica.
Su questo terreno si è combattuta la prova elettorale: non tra destra e sinistra, nel loro significato tradizionale, ma tra politica e anti-politica, tra il riconoscimento dell’etica come istanza ordinatrice e la sua negazione nel nome dell’immediatezza degli interessi. È su questa base che si è stretto un rapporto nuovo e non effimero tra la sinistra e il centro moderato, perché appunto era in gioco in primo luogo la concezione dello Stato.
Questo è il fatto decisivo, e questa è la chiave di interpretazione del voto del 21 aprile 1996: non uno spostamento a sinistra degli equilibri sociali, ma una rivincita della politica, anche se ottenuta di stretta misura.
La vittoria del centro-sinistra è tutta politica, è stata determinata dalla capacità di costruire un più largo sistema di alleanze. Ma ciò significa anche che la crisi della società italiana è ancora tutta aperta e irrisolta. Una lettura della crisi che si fermi al solo aspetto istituzionale finisce per essere deviante, e da questa lettura unilaterale, che sembra essere oggi prevalente, discendono risposte fittizie e illusorie, progetti di ingegneria istituzionale costruiti nel vuoto, senza nessun rapporto con la dinamica reale della società italiana. È il rapporto tra politica e progetto sociale che deve tornare in evidenza, per non restare invischiati in un gioco politico tutto contingente.
La transizione, quindi, sollecita una risposta strategica di alto profilo, sui diversi terreni, per ricostituire le legature sociali che si sono allentate o spezzate, per mettere in moto un processo nuovo di coesione e di socializzazione, ricostruendo così, sulla base di valori condivisi, la stessa identità nazionale.
In assenza di ciò, la politica si riduce a tecnica al servizio dell’oggettività presupposta delle leggi economiche, e la società civile diviene il campo di una feroce competizione senza regole. Per queste ragioni, il dibattito e la ricerca politica hanno la necessità di superare le strettoie in cui oggi si trovano.
Il dominio della retorica
È finora mancata una ricognizione attenta delle dinamiche politiche che si sono aperte, e prevale piuttosto l’uso di formule e di schemi propagandistici che sembrano dir tutto e non dicono nulla: la Seconda Repubblica, democrazia del maggioritario, la fine della partitocrazia e del consociativismo, l’opposizione di società civile e società politica. Con tali mezzi interpretativi, non si afferra la realtà se non nei suoi aspetti più superficiali, e il dibattito politico si avvilisce in un gioco di parole e di simboli.
Se la retorica è la tendenza ad attribuire più valore alle parole che alle cose, possiamo allora dire di trovarci oggi sotto il dominio della retorica.
«La prima cosa da farsi è il raddrizzamento dei nomi», diceva Confucio. E oggi quanti confuciani si vedono in circolazione. I nomi, quelli sì, sono stati raddrizzati, trasfigurati, e nuove élites si presentano come le uniche depositarie del nuovo, le uniche interpreti legittime delle nuove parole sacre. Ma siamo davvero certi che si siano raddrizzate anche le cose? Nella realtà sembra piuttosto essere in atto una grande operazione di trasformismo e di manipolazione. Conta solo l’effetto immaginifico del messaggio, la retorica, appunto, come arte della comunicazione e della persuasione.
Questo oggi è il rischio, di affrontare i problemi ardui della transizione, e quindi della costruzione di un nuovo ordinamento politico, solo con qualche innovazione di immagine e con il lancio sul mercato di nuove sigle e nuove leadership.
Una tale tendenza non riguarda solo la destra e la figura, sicuramente emblematica sotto questo profilo, di Berlusconi. È l’intera vicenda politica italiana che tende a rattrappirsi in un gioco di protagonismi personali e di schermaglie tattiche, con i riflettori puntati su ogni parola e ogni gesto di quelle dieci persone che riempiono di sé i mass-media, mentre restano nell’ombra i nodi reali del Paese.
Interviene qui, con un effetto di ulteriore distorsione, il sistema dell’informazione di massa, che tende alla spettacolarizzazione dell’evento, e che quindi sa raccogliere, di tutto quanto accade nella realtà sociale e politica del Paese, non il suo movimento sostanziale, ma i gesti, le parole gridate, come in un teatro di burattini.
Bisognerà affrontare al più presto, e con la necessaria decisione, il grande tema dell’informazione e reagire all’attuale stato di cose. Se la politica appare così angusta e opaca, ristretta ad un ceto politico avvitato su se stesso, ciò è anche un effetto dei meccanismi distorti della comunicazione, i quali riescono a rappresentare la vita politica italiana in un’ottica ancora più riduttiva, più povera di contenuti e di significati, di quanto non sia nella realtà.
Messi in crisi i partiti come strumenti di organizzazione collettiva, non si determina il passaggio all’autogoverno della società civile, come recita la retorica ufficiale, non si afferma una democrazia più larga e dispiegata, ma si costituisce anzi una casta politica ancora più ristretta ed esclusiva.
L’anti-politica ha sempre l’effetto di sottrarre la politica al controllo democratico e di consegnarla a qualche nuovo potentato. Ed è questo il percorso che finirà per compiersi se la situazione sarà lasciata alla sua dinamica spontanea, se non entrerà in campo un progetto visibile di riforma del sistema politico.
L’anti-politica
L’anti-politica affonda le sue radici negli umori profondi della società, nell’individualismo istintivo che è presente in ciascuno di noi. La destra non fa altro che rivolgersi direttamente a questo sotto fondo pre-politico, corporativo, e non ha bisogno di elaborare un proprio progetto, perché essa concepisce il capitalismo come la società naturale, e le è sufficiente quindi affidarsi alla dinamica spontanea del mercato e ai suoi meccanismi competitivi.
In questa ottica, qualsiasi intervento politico è in sé un elemento negativo, perturbatore, un atto d’autorità che limita la libertà individuale. L’operazione di Forza Italia ha qui il suo fondamento: essa è l’espressione di quel blocco di forze sociali – imprese, lavoro autonomo e anche settori di lavoro dipendente – che pensano e agiscono solo nella prospettiva della competizione e il cui unico parametro di valutazione è il successo.
Rientra pienamente in questa medesima logica anche il libertarismo di Pannella, la cui parabola politica non è, a ben guardare, affatto sorprendente. Essa segue un filo logico, perché in tutte le campagne di Pannella, libertarie, antipartitocratiche, antisindacali, l’idea-guida è la libertà di essere quello che si è, nell’indifferenza per la dimensione etica della vita e per il rapporto con l’altro. Non c’è dunque oggi involuzione, perché da sempre c’è stata una radice di destra, anche se variamente camuffata e manipolata.
Il confronto tra destra e sinistra avviene quindi su due piani tra loro sfasati, e le stesse parole della politica finiscono per assumere un significato ambiguo, cangiante, a seconda della prospettiva nella quale sono considerate.
Le parole sono ormai quasi tutte usurate, e possono essere manipolate e deformate in mille modi, come è nella tradizione dell’arte retorica. Per questo bisogna guardare alla sostanza, al contenuto culturale profondo, e soprattutto partire dalla società e dai processi che la attraversano, perché è nella società stessa la radice di una possibile involuzione della politica, sono qui le possibili basi di massa di una politica di destra.
Il fatto è che la società italiana oggi è percorsa, in larga parte, da umori distruttivi, da uno spirito di rancore che finisce per corroderne tutti gli elementi di coesione, e ciò la espone alle più varie manovre diversive. La Lega per prima si è alimentata di questa linfa, e ora altri soggetti, anche più spregiudicati e pericolosi, giocano la carta della demagogia qualunquista.
L’analisi politica deve prendere le mosse dalla consapevolezza che la condizione della nazione e del suo spirito pubblico presenta oggi molti sintomi di disgregazione. Occorrerà dunque un lavoro ricostruttivo, da realizzare con pazienza e con metodo, con i tempi lunghi che sono propri di qualsiasi opera non effimera, con il senso profondo della realtà e non con i giochi della retorica. È il momento di una politica raccolta, meditata, misurata. Altrimenti il sistema politico impazzisce, travolto da processi che non riesce a controllare, da un permanente stato di emotività e di tensione, che impedisce sia la formazione di una nuova classe dirigente sia l’attuazione di un disegno ragionato di riforma delle istituzioni.
Se questo è il quadro, e se questi sono i tempi della politica, è necessaria una strategia di lungo periodo: una linea politica tutta giocata sul momento elettorale finirebbe per essere illusoria e miope.
Sistema elettorale e presidenzialismo
È trascorso un anno disputando intorno alla data delle elezioni, reclamate da alcuni, a destra e anche a sinistra, come il momento risolutivo in cui si riconsegna la parola al popolo, trascurando totalmente sia le necessità oggettive del Paese in una fase assai critica per il suo equilibrio economico e per il suo ruolo nel contesto internazionale, sia le regole costituzionali tuttora vigenti, per le quali lo scioglimento anticipato delle Camere è solo l’extrema ratio, la via obbligata nel momento in cui il Parlamento non è in grado di esprimere nessuna maggioranza di governo.
L’enfasi sulle elezioni era il corrispettivo dell’enfasi sul “principio maggioritario”: bisogna votare per il solo motivo che il governo “tecnico” non rientra negli schemi del bipolarismo ed è quindi un’anomalia da rimuovere. Ora le elezioni si sono svolte, e il tormentone si è infine concluso. Resta comunque significativa tutta la vicenda della disputa intorno alla data delle elezioni, perché essa ha messo in luce una concezione della democrazia parlamentare del tutto estranea alle regole costituzionali, in quanto trae dall’approvazione della legge elettorale maggioritaria un nuovo e diverso principio regolatore, come se già nei fatti avessimo introdotto una legittimazione popolare diretta dell’esecutivo.
La stessa contrapposizione di governi tecnici e di governi politici mi sembra concettualmente non fondata. All’analisi dei programmi e delle iniziative politiche concrete si sono sostituiti schemi politologici astratti.
In particolare, c’è la tendenza a concentrare tutta l’attenzione sulla questione del principio maggioritario, considerato il cardine di una coerente politica riformatrice, e se ne ricava il seguente semplicissimo dilemma: o si porta a compimento la riforma in senso maggioritario del nostro ordinamento politico, e si modifica in questa direzione la stessa carta costituzionale, o si regredisce verso la consociazione partitocratica. Considero tale dilemma del tutto fuorviante, perché si introduce così una semplificazione astratta, come se l’adozione della nuova legge elettorale determinasse di per sé una cesura, una rottura storica, e il passaggio quindi alla tanto decantata Seconda Repubblica.
I sistemi elettorali hanno solo una funzione strumentale e tecnica, e possono essere più o meno adeguati e opportuni a seconda del contesto politico nel quale vengono inseriti. Per questo la Costituzione non prescrive nulla in materia, e lascia alla legislazione ordinaria piena facoltà di decidere tra i diversi meccanismi possibili, e di innovare ogni volta che lo si ritenga necessario.
La legge elettorale, dunque, presa in questa sua ristretta accezione tecnica, interviene solo sulle modalità di elezione del Parlamento, e non modifica in nessun modo i rapporti tra i diversi organi dello Stato, continuando ad essere il Parlamento l’esclusiva fonte di legittimazione dei governi, e continuando a funzionare una democrazia rappresentativa, senza mandato popolare diretto. Si può ritenere che questo sistema debba essere radicalmente modificato, ma nella logica costituzionale non c’è nessun automatismo che renda inevitabile, dopo l’adozione della legge maggioritaria, la trasformazione del sistema parlamentare in un sistema presidenziale.
Chi sostiene questa tesi, Mario Segni in testa, compie una mistificazione. E io credo che, essendo ancora in fase di rodaggio e di sperimentazione la nuova legge elettorale, con un sistema politico che stenta a ristrutturarsi e che è tuttora attraversato da fortissime tensioni, un’ulteriore accelerazione con l’adozione del modello presidenzialista avrebbe effetti dirompenti, alimentando personalismi, demagogie populiste e pulsioni autoritarie che già appaiono oggi nel panorama politico come un segnale inquietante.
La formula del “sindaco d’Italia” è, sotto questo profilo, esemplare, perché essa tende alla più arbitraria e pericolosa manipolazione dei problemi costituzionali, mettendo sullo stesso piano il governo di un grande Stato nazionale e quello di un municipio, e ignorando quindi tutta la cultura del costituzionalismo moderno che consiste essenzialmente nella ricerca di un equilibrio tra i diversi organi dello Stato. Che questa formula abbia trovato proseliti anche a sinistra è un segno dei tempi, della confusione e della disinvoltura con cui vengono affrontati problemi di questa portata. Il criterio fondamentale resta quello dell’equilibrio istituzionale, per impedire la concentrazione di tutto il potere decisionale in un unico organo.
Se è chiara questa premessa, possono essere prese in esame diverse possibili soluzioni, e anche forme di elezione diretta non possono essere aprioristicamente rifiutate, a condizione che sia chiara e convincente una complessiva architettura costituzionale. La ricerca di un’intesa ragionata ed equilibrata su determinate ipotesi di riforma può essere quindi un fatto positivo, e avere tentato questa strada è un segno importante, da parte della sinistra, di maturità e di disponibilità all’innovazione. Ma devono essere chiare le coordinate di fondo, i lineamenti di un progetto istituzionale che sia in sé coerente, e vanno perciò respinte e combattute tutte le semplificazioni propagandistiche oggi di moda.
La destra spinge verso forme di democrazia plebiscitaria, di semplificazione autoritaria del sistema, in cui tutto si ridurrebbe al rapporto carismatico tra il popolo e il leader, e propone non una riforma costituzionale, ma una riscrittura del patto e l’adozione di una diversa filosofia ispiratrice.
Il presidenzialismo diviene, in questa visione, la proiezione simbolica, mitologica, di una forma politica che si riassume nel rapporto diretto tra il popolo e il leader, negando il ruolo sia dei partiti, sia delle rappresentanze parlamentari, sia del più complessivo tessuto democratico in cui si organizza la società.
Democrazia reale versus democrazia virtuale
Questa è la posta in gioco. È allora importante che la sinistra abbia chiara la necessità di una proposta alternativa, che miri allo sviluppo e alla diffusione del potere democratico, nei diversi ambiti. Il concetto discriminante è il cittadino-sovrano, in alternativa al cittadino-consumatore, è la democrazia reale contro la democrazia virtuale. È la politica come esercizio di sovranità. Se esiste un progetto, sostenuto da chiare e forti motivazioni, allora si può aprire senza timori un dialogo con tutti, nella ricerca di possibili intese e di accettabili compromessi.
Il pericolo, per la sinistra, è rappresentato da quella particolare specie di politici cosiddetti “realisti”, i quali, non avendo idee proprie, considerano come terreno obbligato e oggettivo quello predisposto dalle idee degli altri. È il realismo, non so se ingenuo o disperato o cinico, di chi considera come eventi oggettivi, naturali, i processi in atto di restringimento della democrazia, di spettacolarizzazione e personalizzazione della politica, e si adatta quindi a svolgere la sua parte, invero piuttosto modesta, dentro questo sistema di regole. Ma questa è la parte del topo nella trappola. Ci si illude, così, di rendere la sinistra più innovativa e più competitiva, mentre in realtà la si rende superflua, perché il primo e fondamentale terreno di competizione riguarda la concezione e la pratica della democrazia, e se la sinistra perde su questo terreno perde la sua stessa ragion d’essere. Nel complesso movimento d’opinione che ha determinato la crisi del vecchio sistema politico e che si è espresso nel referendum sulla legge elettorale, erano presenti, in realtà, motivazioni diverse e contraddittorie: domande di una democrazia più sostanziale e più vicina ai cittadini, ma anche spinte di segno differente. Occorre oggi, al di là dell’enfasi retorica, un bilancio realistico di questa esperienza.
La nuova legge elettorale era funzionale all’esigenza di introdurre un elemento di dinamismo e di innovazione in un sistema politico ormai paralizzato. Si tendeva così a favorire, a determinate condizioni, una maggiore stabilità degli esecutivi, e a incentivare un processo di aggregazione delle forze politiche nella prospettiva di un sistema bipolare.
Con il referendum, inoltre, questa riforma si caricava di un più ampio significato politico e simbolico, proprio per il fatto di essere il punto di arrivo di un vasto movimento di opinione che metteva in discussione le forme tradizionali della politica e i processi degenerativi che avevano investito il sistema dei partiti.
Avviene spesso nei referendum che il singolo quesito tecnico venga trasceso, e diventi l’occasione per esprimere una domanda di più ampia portata: in questo caso la domanda, anche se nasceva in un contesto di motivazioni spesso nebulose, si riassumeva nell’esigenza di dar vita ad una politica più vicina ai cittadini, più controllabile, più democratica.
Ma tutti questi risultati, anche quelli più limitati, non sono garantiti automaticamente, perché dipendono dalle scelte e dai comportamenti politici sia dei partiti che degli elettori, ed è quindi necessario prevedere un periodo non breve di assestamento. Così è stato dopo le elezioni del 27 marzo e così continua ad essere oggi, con la presenza di un numero ancora grande di variabili possibili e di incognite.
L’essenziale ragion d’essere del referendum e della legge elettorale ha, tutto sommato, raggiunto il suo obiettivo, in quanto si è dinamizzata tutta la situazione politica, ma non si poteva certo produrre il miracolo di far nascere dal nulla un sistema politico del tutto nuovo e già immediatamente funzionante ed efficace.
Ora, anche di fronte ai pericolosi segni involutivi in atto, non avrebbe nessun senso rimettere in discussione le scelte che democraticamente si sono compiute, ma si tratta di sperimentare i nuovi meccanismi, di vederne più attentamente tutte le implicazioni, di governare le nuove dinamiche politiche che sono state prodotte. E a questo punto rientra in campo la politica, perché infine le riforme istituzionali non possono essere autosufficienti e chiamano in causa i soggetti politici e i loro concreti comportamenti.
Il problema del centro
Le forze politiche sono state costrette, tutte, a ridefinire la propria identità e le proprie strategie. Una spinta nuova ha costretto a rendere esplicito il quadro delle alleanze, orientando l’intero sistema verso una logica di tipo bipolare. Da un sistema imperniato sul centro, che di volta in volta procede a cooptare altre forze nell’area di governo, stiamo passando ad un sistema imperniato sulla concorrenza di due poli alternativi. Un tale mutamento, ha investito in primo luogo gli eredi della DC, determinando in quest’area politica una serie di rotture e di ridislocazioni, poiché non è più praticabile la tradizionale politica centrista.
Ciò non significa che il centro sia scomparso, che le sue ragioni si siano dissolte, ma solo che esso non è più autosufficiente. Per questo, un esito di puro e semplice annullamento del patrimonio politico del cattolicesimo democratico, il quale appunto ha rappresentato in Italia le ragioni di un centro moderato, non è prevedibile né, tanto meno, auspicabile.
Non credo che sia fondato il timore di un ritorno del “Grande Centro”: si è avviato un nuovo processo politico, e indietro non si torna. Ma il cammino è tutt’altro che lineare, è aperto ad esiti diversi, e c’è spazio per diversi progetti. Accettare o respingere un progetto politico solo in base all’appartenenza ad uno schieramento significherebbe riprodurre la vecchia prepotenza partitocratica, la quale pretendeva solo atti di fedeltà e di sottomissione. È giusto invece dialogare, senza schemi, con qualunque forza abbia una capacità vera di elaborazione e di proposta. Da questo confronto aperto nascerà il nuovo sistema politico, e solo in esso prenderanno significato le parole convenzionali di destra, sinistra e centro. Pretendere che oggi sia già tutto chiaro, che il bipolarismo sia già costruito e che a ciascuno sia data ormai solo la libertà di schierarsi da una parte o dall’ altra, mi sembra il frutto di un’astratta semplificazione.
In una fase di incerta transizione l’atteggiamento più produttivo è quello di tenere la mente aperta a tutte le possibili evoluzioni e di non essere prigionieri di schemi dottrinari. II sistema politico va sì ristrutturato, ma non dissanguato: esso ha bisogno di soggetti forti, dotati di un proprio profilo storico e culturale, capaci perciò di dar vita a movimenti collettivi non effimeri. In questo contesto va preso sul serio anche un fenomeno come quello della Lega, per molti aspetti negativo, ma pur tuttavia espressione di forze reali.
II modello opposto è quello del grande e amorfo contenitore elettorale, in cui il leader è tutto e il resto è solo truppa; è il modello di un bipolarismo snervato, senz’anima, nel quale la politica funziona solo come competizione di comitati elettorali, con il supporto di esperti di sondaggi e di strateghi della comunicazione.
Ciò è del tutto funzionale in una prospettiva di destra, nella logica dell’anti-politica, la quale appunto nega la politica come luogo dell’identità collettiva e dell’etica pubblica. La politica, in questa formulazione, non è altro che un segmento del mercato, una delle forme che assume il principio di competitività.
Ma tutta la prospettiva della nostra vita democratica sarebbe gravemente compromessa se alla fine il modello “berlusconiano” – per così dire – si affermasse come la forma esclusiva di organizzazione politica.
Le forme della politica
Le elezioni del 21 aprile hanno bloccato l’aggressività della destra, ma il problema delle forme della politica è ancora irrisolto. II successo della sinistra è il frutto di una intelligente strategia di alleanze, ma non implica ancora uno spostamento reale nella società, nei suoi equilibri, nelle sue dinamiche di fondo: se si fosse votato con il sistema proporzionale, si sarebbe definito un risultato di sostanziale stabilizzazione. La svolta, quindi, è tutta interna agli equilibri politici, ma ciò costituisce solo la premessa per poter affrontare i problemi reali della società italiana e della sua vita democratica.
Il voto alla Lega è lì a testimoniare dei pericoli di disgregazione della coesione nazionale, e le richieste che provengono dal Nord e dal Sud dell’Italia non si prestano ad una facile composizione, ma richiedono una forte capacità di iniziativa e di direzione politica.
La sinistra ha conquistato condizioni favorevoli: ora comincia il lavoro vero. Con quali strumenti? Il problema delle forme della democrazia torna ad essere centrale, perché la vittoria politica si può consolidare solo attivando un circuito democratico reale, arrestando i processi di spoliticizzazione e di passivizzazione.
Intorno a questo nodo la partita è tutta aperta. Non è ancora chiaro infatti che cosa sia e che cosa si proponga di divenire l’Ulivo di Prodi. Esso è esposto a due opposti rischi.
Il primo è che non venga superata l’attuale frammentazione, che non nasca quindi nulla di nuovo e di vitale, che ci sia solo un cartello elettorale precario nel quale ciascuno difende le posizioni acquisite e il proprio particolarismo. Il secondo rischio è che si imbocchi la strada di una sorta di Forza Italia di sinistra, tutta giocata sull’immagine del leader e sulle tecniche di comunicazione, le quali trasmettono non delle proposte politiche, ma solo delle suggestioni emotive.
Nel primo caso il declino è sicuro, nel secondo la vittoria è solo apparente, perché pagata al prezzo di una sclerosi della vita democratica. A questo punto la stessa distinzione di destra e sinistra sarebbe del tutto evanescente.
Per sfuggire a questi opposti possibili esiti, occorre un lavoro paziente di ricostruzione e di riforma del sistema politico, senza scorciatoie e senza improvvisazioni, e avendo chiaro che c’è bisogno di nuove forme organizzative, di aggregazioni più ampie, lasciando alle spalle le vecchie identità.
Qualcosa si è mosso in questa direzione, e il risultato elettorale certamente contribuisce a dare all’Ulivo una propria autonoma forza di aggregazione. È indicativo che i voti per la coalizione siano stati largamente superiori alla somma dei voti per le singole liste di partito. Questo è il terreno su cui costruire un lavoro politico di tipo nuovo, che superi le vecchie appartenenze e getti le basi di una nuova identità politica e culturale.
L’Ulivo ha valore come un progetto per il futuro, ancora tutto da costruire, a cui occorre dare un’anima, ovvero un insieme forte di motivazioni, di scelte programmatiche, di valori, e ciò può avvenire avviando un confronto serio tra le diverse correnti politiche che a questo progetto possono contribuire.
Il punto d’arrivo può essere, in prospettiva, la creazione di un’unica grande formazione politica della sinistra democratica, ma ciò richiede una serie di passaggi e un processo di maturazione, e l’operazione può essere compromessa da atti precipitosi e da forzature intempestive.
Il progetto del centro-sinistra
Per ora, è importante l’avvio di un lavoro politico che ridimensioni i particolarismi e le piccole logiche di bottega, e che si misuri con le grandi e complesse questioni di strategia, politica, istituzionale e sociale.
Nella coalizione di centro-sinistra convergono diverse tradizioni e diverse culture, che vanno riconosciute e valorizzate come tali, in una visione non di tipo statico, ma costruendo via via, nel confronto politico, possibili sintesi e prospettive strategiche nuove, adeguate al nuovo contesto nazionale e mondiale. Occorre, in sostanza, proiettarsi oltre la difesa di identità storiche ormai inerti, per costruire collettivamente gli strumenti teorici e pratici di una politica che guardi al futuro.
In questa ricerca è importante anche il contributo di posizioni radicali, le quali riflettono punti di vista e forme di coscienza reali, rappresentative di settori non marginali del mondo del lavoro.
Il pericolo è che queste posizioni non entrino in un confronto più largo e si chiudano in se stesse, dentro una logica di autosufficienza e di contrapposizione di tipo ideologico, di principio, la quale riproduce l’antica tendenza storica della sinistra a trasformare le differenze in scissioni, a bloccare la discussione pluralista nell’affermazione dottrinaria della verità e dell’errore.
A questa possibile deriva è pericolosamente esposto il partito di Rifondazione Comunista, che ancora non sembra agire dentro una logica di coalizione, ma piuttosto nel miraggio di poter rappresentare il nucleo di una futura alternativa. In questo modo, esso finirebbe per tagliarsi fuori dai processi reali e per non contribuire in nessun modo a costruire le forme di un sistema politico rinnovato. Nella nuova situazione che si è determinata dopo il voto, occorre realizzare una linea di dialogo e di confronto, e far maturare così condizioni politiche più aperte per evitare arroccamenti ed esiti distruttivi.
La sinistra, tutta la sinistra, è messa alla prova. Il processo di riforma del sistema dei partiti si presenta assai complesso, e ancora molte e tenaci sono le resistenze, le identità chiuse, proiettate sul passato più che sul futuro.
Occorre avere chiara una linea di marcia, e lavorare con pazienza, attrezzandosi per una strategia di lungo periodo. Alcuni interventi istituzionali, come il passaggio ad un sistema elettorale a doppio turno, possono incentivare una più rapida evoluzione, ma in questo campo non ci sono mai misure risolutive, e ciò che conta è essenzialmente la chiarezza della prospettiva e la coerenza con la quale essa viene perseguita.
Il vero banco di prova, a mio giudizio, su cui si misura la validità di una proposta politica della sinistra, sta nella capacità di offrire una prospettiva nuova di sviluppo democratico, e di contrastare quindi in modo efficace le numerose spinte alla “semplificazione autoritaria”, alla concentrazione di tutto il potere decisionale in una leadership forte, capace di sottrarsi ai condizionamenti e ai vincoli del consenso sociale e di togliere peso alla domanda democratica. Che questa sia una soluzione efficace per le società complesse è del tutto illusorio, perché ciò di cui c’è bisogno è la costruzione di una classe dirigente, ai diversi livelli e nei diversi ambiti, è la pluralità di centri di decisione e di, governo, è la forza dei corpi intermedi della società. E quindi la formazione di una poliarchia, nella quale diversi poteri si confrontino e si condizionino reciprocamente.
È singolare che, dopo tante analisi sofisticate intorno alla società complessa, nel dibattito politico riemerga l’idea del “principe”, del decisore, di un luogo esclusivo di comando e di regolazione. Tutti i processi reali, al contrario, mostrano come, nell’epoca della mondializzazione, la funzione di governo non possa che essere concepita come una rete di funzioni e di centri di decisione, ai diversi livelli. Istituzioni politiche transnazionali, da un lato, e sistemi territoriali forti, dall’altro, sono le risposte innovative ai cambiamenti strutturali in atto, mentre la vecchia forma dello Stato-nazione, ormai in crisi, non riesce più ad esercitare una sovranità piena ed effettiva sui processi reali.
Vi è inoltre la necessità di istituzioni regolatrici indipendenti, sottratte alla competizione politica, le quali funzionino come elementi di garanzia e di neutralità in una serie di campi che è bene siano svincolati dal conflitto delle forze politiche (il potere giudiziario, l’informazione, la banca centrale, l’anti-trust, gli organi di vigilanza).
E infine occorre anche prendere atto del fatto che la “politicità” oggi si esprime non solo nelle forme classiche della rappresentanza partitica, ma attraverso i diversi canali dell’associazionismo democratico e della rappresentanza dei grandi corpi sociali, e ciò implica l’adozione di un nuovo stile di governo, non astrattamente autoritativo e decisionista, ma fondato sul confronto e su procedure di concertazione con le forze sociali.
Questa è la frontiera della modernità e dell’innovazione, e con questo metro vanno misurate le diverse ipotesi e proposte di riforma istituzionale. Solo così, si possono aprire nuovi spazi di partecipazione democratica e si può rispondere concretamente a quel bisogno di una politica più vicina ai cittadini che aveva alimentato il movimento referendario.
Per questo il presidenzialismo, almeno nelle sue forme più grossolane e semplificate, è una risposta sbagliata, perché si muove esattamente nella direzione opposta. L’insistenza della destra su questo punto è sospetta. La destra in realtà ha in mente un vero e proprio stravolgimento dell’equilibrio costituzionale, e perciò è giustificato l’allarme, non tanto sul passato e sulle vecchie ideologie, quanto sul futuro del nostro Paese.
Costituzione e “fase costituente”
Non c’è ancora una base condivisa di regole e di valori comuni, la quale possa consentire un’alternanza che non metta a rischio le basi della convivenza democratica. Predicare la legittimazione reciproca, come qualcuno suggerisce, non è chiaro che cosa significhi in assenza di questi chiarimenti di fondo. E solo un problema soggettivo o di fair play? Basta convincerci che non ci sono pericoli per la democrazia perché essi siano effettivamente scongiurati? È questa una forma curiosa di soggettivismo. «Esse est percipi», diceva il vescovo-filosofo Berkeley, esiste solo ciò che ci rappresentiamo. Ma non mi sembra una buona e realistica linea di condotta nel campo della politica.
La reciproca legittimazione, che sicuramente è in sé un evento auspicabile, può avvenire sulla base di un riconoscimento comune di regole e di principi democratici, ma è proprio su questo terreno che il confronto, almeno per il momento, si è inceppato.
Il nostro sistema politico si presenta ancora come un sistema incompiuto, intrinsecamente debole, come un bipolarismo zoppo. E l’insistente attacco ai principi costituzionali, il tentativo di delegittimazione e di archiviazione di tutto ciò che propagandisticamente viene catalogato nella categoria infamante della “Prima Repubblica”, fa sì che il conflitto politico travalichi la sua dimensione fisiologica e normale per investire questioni di principio, mettendo in causa gli elementi fondativi del patto su cui si reggono la convivenza democratica e l’unità nazionale. C’è dunque ancora un grande lavoro da fare, proprio sul terreno delle regole e delle riforme istituzionali, per cercare di rimuovere questa anomalia e i rischi che essa comporta.
Ma questo lavoro può essere proficuo e produttivo solo se si inquadrano i temi istituzionali in un’ottica più larga, affrontando i problemi della vita democratica del Paese in tutta la loro ampiezza. Infatti non c’è solo il problema della governabilità e della stabilizzazione della funzione di governo.
Abbiamo bisogno di affrontare una serie di problemi, che qui vengono soltanto accennati e che possono dare concretezza ad una prospettiva democratica: lo sviluppo delle forme di autogoverno, con la riforma federalista dello Stato; la regolamentazione dell’istituto del referendum, non per ridurne il rilievo, ma per una sua utilizzazione più ponderata ed efficace; il problema dei costi della politica, e quindi del finanziamento di partiti e di associazioni a garanzia della possibilità di accesso per tutti alla vita politica; il problema della selezione del personale politico e dei meccanismi possibili (elezioni primarie, consultazioni o altro) per la scelta dei candidati; e infine il problema complesso della democrazia in campo economico, delle forme possibili di controllo e di partecipazione dei lavoratori in un mercato aperto, non ristretto come è oggi a pochi gruppi oligopolistici.
Si può quindi convenire che, per la portata complessiva dei problemi aperti, ci troviamo oggi in una “fase costituente”, nel senso che sono in causa questioni di grande rilievo costituzionale. Non si tratta solo dell’ordinamento dello Stato e delle sue possibili riforme, ma del rapporto che tutto ciò ha con la dinamica sociale e con l’effettività dei fondamentali diritti di cittadinanza. Una politica costituzionale non può essere solo la definizione di una nuova architettura delle istituzioni, perché le stesse istituzioni vanno pensate in un rapporto stretto con il progetto di società.
Basti pensare, ad esempio, a tutte le correlazioni tra la riforma federalista dello Stato e il tema dei diritti, dell’eguaglianza, della solidarietà nazionale. In questo senso, non è possibile separare astrattamente la prima e la seconda parte della Costituzione, perché esse sono legate da un nesso di coerenza che non può essere aggirato, e perché anche sul terreno dei diritti fondamentali possono rendersi necessarie, nella nuova situazione storica, definizioni nuove, più aderenti alla realtà.
Su nuovi terreni, oggi decisivi, come quelli dell’informazione, dell’ambiente, dei nuovi livelli di sovranità su scala europea, è sicuramente utile un’elaborazione più aggiornata delle norme costituzionali. Ma per aprire la prospettiva di un nuovo sviluppo democratico, non occorre né riscrivere la Costituzione né affidarci all’evento mitico di una nuova assemblea costituente. Il processo costituente è un processo costantemente aperto, che può avanzare di volta in volta quando maturano le condizioni politiche e i consensi necessari per determinate riforme, mentre la decisione di una revisione generale della Costituzione avrebbe il significato di rimettere in discussione i principi di fondo con l’effetto politico inevitabile di aprire il varco a pericolose manipolazioni autoritarie.
L’impianto generale della Costituzione va salvaguardato, perché continua ad essere una risorsa politica fondamentale per contrastare le spinte alla disgregazione sociale e al restringimento degli spazi di democrazia.
Penso quindi che si debbano seguire le procedure di revisione che la stessa Costituzione prevede, rafforzando i meccanismi di garanzia con la fissazione di un quorum più elevato, per assicurare il carattere non di parte di qualsiasi decisione. Per questa via, si possono cominciare a realizzare le riforme già mature nella coscienza pubblica e condivise da un largo schieramento politico, come è il caso della definizione di un nuovo rapporto tra Stato centrale e poteri locali, in una linea di federalismo democratico, utilizzando le proposte della Commissione bicamerale della penultima legislatura e tutte le successive elaborazioni sia di singole forze politiche sia di autorevoli centri di ricerca.
In una linea di gradualità si possono risolvere i problemi già maturi e continuare l’approfondimento delle materie intorno alle quali il dibattito politico è ancora aperto. Se invece ci si affida all’avvento di una Grande Riforma, ad un atto solenne di riscrittura del patto, si corre il rischio di alimentare nell’opinione pubblica un’aspettativa illusoria di rigenerazione senza riuscire a realizzare nessuna riforma concreta, il che determinerebbe un gravissimo contraccolpo nel rapporto di fiducia, già oggi seriamente minato, tra cittadini e istituzioni.
Occorre per questo una precisa strategia di intervento che affronti da subito le questioni più urgenti, anche nel quadro dell’attuale Costituzione: trasferimento di poteri e di risorse a Regioni ed enti locali, riforma fiscale, funzionamento della macchina amministrativa. Solo così il nuovo governo può acquistare credibilità e consenso, con atti di efficacia immediata e senza aspettare i tempi necessariamente lunghi delle riforme costituzionali.
Va per questo riformulata l’agenda politica in materia di riforme, mettendo al primo posto tutto ciò che riguarda il concreto rapporto tra Stato e cittadini, ovvero la trasformazione della macchina amministrativa e lo sviluppo dell’autogoverno locale. Si tratta così di ricostruire su nuove e più solide basi la stessa unità nazionale.
Il ruolo del sindacato
Oggi c’è bisogno di una politica che si impegni in una prospettiva a lungo termine e riattivi le energie democratiche della società. Anche il sindacato, nella sua autonomia, partecipa a questo processo, e non può restare neutrale di fronte alle grandi alternative aperte nel Paese, perché la stessa azione sindacale avrà forza e capacità rappresentativa se si collocherà in un quadro forte di garanzie democratiche.
Se la stagione delle riforme deve ancora iniziare, e se sono ancora da definire il senso, l’indirizzo e il contenuto sociale del nuovo edificio istituzionale, un sindacato chiuso in se stesso, in una concezione angusta della sua autonomia, finirebbe per assecondare processi involutivi profondi e per essere esso stesso travolto. Che il sindacato si misuri con questi temi può apparire, in superficie, come un’impropria invadenza nel campo della politica. Io credo, al contrario, che non ci si possa sottrarre ad una discussione a tutto campo, soprattutto in un momento di “transizione”, nel quale sono in gioco la natura dello Stato democratico e l’equilibrio dei poteri.
Il sindacato è anch’ esso attraversato dai processi di cambiamento che investono la società nel suo insieme, e non difenderà la sua autonomia delimitando una propria esclusiva area di influenza, ma intervenendo sui problemi politici e sociali nella loro interezza, in base al proprio specifico punto di osservazione. Senza lungimiranza strategica, non c’è autonomia, né capacità di intervento sulla realtà, ma solo una possibilità di sopravvivenza subalterna dentro le categorie classiche del corporativismo. I fini della politica sono in questo caso prefissati e si trovano comunque al di fuori della portata dell’azione sindacale: resterebbe solo il campo dell’interesse economico immediato, la pratica del conflitto fine a se stesso, nell’indifferenza per i contenuti dell’azione rivendicativa. Funziona allora solo la logica della forza, e si rinsaldano le gerarchie e le disuguaglianze di fatto esistenti anche tra i lavoratori.
La riduzione del sindacato a struttura di servizio per i conflitti sociali esistenti, presi nella loro immediatezza, finisce per essere, anche quando si ammanta di una ideologia di sinistra, del tutto funzionale alla logica del mercato, ai suoi processi di inclusione e di esclusione sociale. Ecco perché il “mestiere” del sindacato non può essere motivato solo in termini economicistici, ma deve essere guidato da un “progetto di società”, e quindi invadere necessariamente il campo della politica, proprio per essere coerente con le sue stesse autonome finalità.
Troppo spesso l’autonomia del sindacato viene concepita in termini restrittivi, e tutto ciò che va oltre la dimensione strettamente contrattuale appare come un’impropria azione di supplenza e come un pericolo per la natura stessa del sindacato. Io penso, al contrario, che si debbano esplorare con grande coraggio tutte le possibilità di affermare la politicità dell’azione sindacale e il suo rilievo anche sotto il profilo istituzionale.
La crisi della politica è crisi dell’idea della politica come sfera separata dalla società, è crisi di un modello di regolazione che aveva come tramite esclusivo i partiti politici. Da tale crisi deriva l’esigenza di una dimensione politica più ampia, nella quale entrino a pieno titolo anche altri soggetti, le forze sociali, l’associazionismo democratico, le varie forme di autogoverno della società. D’altra parte, la frontiera del conflitto si sposta dal singolo luogo di produzione alla struttura sociale presa nella sua dimensione più complessiva.
Il problema centrale che va oggi affrontato è il processo di esclusione, è la contraddizione tra sviluppo capitalistico e coesione sociale: è quindi un problema che ha una fortissima valenza politica. C’è allora bisogno di un sindacato che non sia confinato in una visione arcaica del conflitto di classe, che non abbia più come riferimento esclusivo la grande fabbrica fordista, ma che sia in grado di affrontare e di risolvere i problemi sociali, l’insieme complesso delle tensioni e contraddizioni che attraversano la società di oggi, in un confronto aperto con tutti gli interlocutori, sociali e istituzionali, e vedendo riconosciuta una propria essenziale funzione nella definizione delle fondamentali scelte strategiche.
La vicenda della riforma del sistema previdenziale costituisce un punto di riferimento e un modello di ciò che può essere in prospettiva il ruolo del sindacato, autonomo ma politico, non collaterale a nessuna forza politica ma cosciente di un proprio ruolo nel cuore del sistema istituzionale.
Ciò comporta alcune precise e ineludibili conseguenze sulle forme della rappresentanza sindacale e sulla sua necessaria regolazione legislativa, in quanto i diritti sindacali dei lavoratori hanno un valore di principio e devono essere garantiti con norme di valore universale. Se il sindacato rivendica un ruolo istituzionale, deve garantire totale trasparenza democratica nel rapporto con i lavoratori.
Il sindacato unitario può nascere su due scelte fondamentali e inscindibili: assunzione di responsabilità politica e piena democratizzazione. In questa difficile transizione, aperta a gravi rischi di involuzione, c’è bisogno di soggetti democratici forti, e tra questi il sindacato può concorrere da protagonista a costruire una vita democratica più ricca e più compiuta. A condizione che non si rinchiuda in se stesso e non si adatti pregiudizialmente a svolgere un ruolo marginale e subalterno.
C’è spesso, nei momenti di difficoltà, la tendenza a ridimensionare le proprie ambizioni e a prefissarsi obiettivi più limitati. È un errore, perché così si indebolisce la propria forza e non vengono raggiunti neppure quegli obiettivi più modesti. È invece proprio questo il momento, per il sindacato, di tracciare una più ambiziosa strategia.
 antipolitica
antipoliticaBusta: 34
Estremi cronologici: 1996
Autore: Riccardo Terzi, Piero Barcellona, Franco Cassano, Antonio Cantaro
Descrizione fisica: Volume, b/n, 137 pp.
Tipo: Scritti
Serie: Scritti Politici - Riflessioni politiche -
Pubblicazione: Ediesse, Roma, 1996

