FINE DEL SOCIALE?
Intervento di Riccardo Terzi
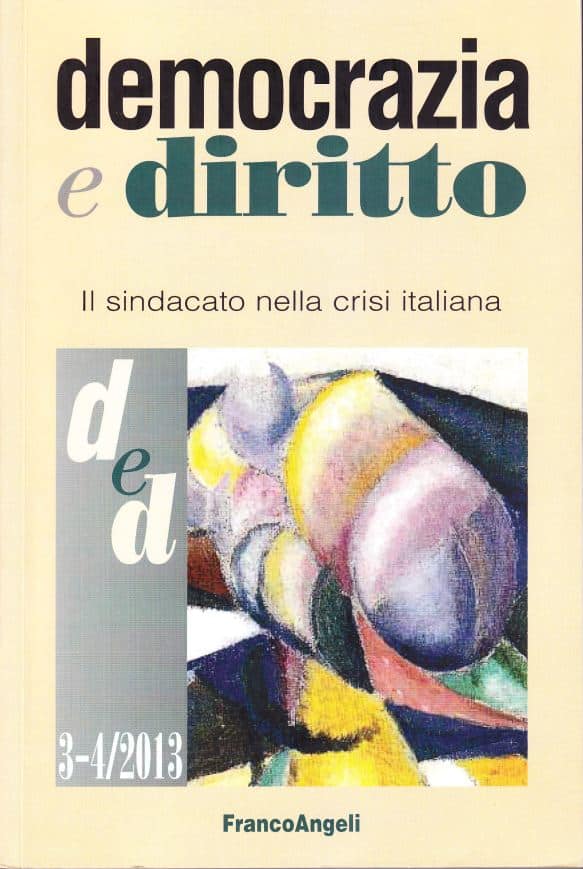 Una grande organizzazione corre sempre il rischio di essere paralizzata dalla sua pesantezza. Il movimento iniziale deve accumulare forza, e per questo si fa istituzione, e a un certo punto l’istituzione vive di se stessa, della sua autoconservazione, e perde di vista le sue finalità originarie. Si compie così un rovesciamento nel rapporto tra il mezzo e il fine, e ciò che conta è solo la potenza del mezzo, che ha in se stesso la ragione sufficiente della propria esistenza.
Una grande organizzazione corre sempre il rischio di essere paralizzata dalla sua pesantezza. Il movimento iniziale deve accumulare forza, e per questo si fa istituzione, e a un certo punto l’istituzione vive di se stessa, della sua autoconservazione, e perde di vista le sue finalità originarie. Si compie così un rovesciamento nel rapporto tra il mezzo e il fine, e ciò che conta è solo la potenza del mezzo, che ha in se stesso la ragione sufficiente della propria esistenza.
Tutto questo processo, di cui la storia ci offre molteplici manifestazioni e varianti, può essere inteso come il risultato inevitabile di una dialettica storica, la quale produce sempre e necessariamente una burocratizzazione di tutte le strutture, il che vuol dire anche il dominio delle oligarchie e degli apparati di potere. È questa la nota tesi di Michels, che in questo destino vede l’ineluttabile frantumarsi di tutti gli slanci rivoluzionari: ciò che nasce come domanda di libertà si capovolge sempre in una nuova struttura di comando, in una nuova gerarchia. Si può rifiutare l’idea che si tratti di una legge assoluta, ma non si può certo negare l’evidenza storica di tutti i processi che hanno avuto, e hanno tuttora, i segni della burocratizzazione, del mezzo che si sostituisce al fine.
Tenere insieme, in un rapporto forte di coerenza, l’ordine dei mezzi e l’ordine dei fini, è questa la difficile arte della politica. È questa la missione del “principe”, in quanto unione di forza e di idealità politica, secondo le due grandi lezioni di Machiavelli e di Gramsci. Il dramma della nostra attuale condizione politica sta proprio nel fatto che questo legame si è del tutto spezzato, e non si vede nessun principe all’orizzonte. Ci sono i professionisti dell’utopia, privi di qualsiasi forza, e ci sono sull’altro versante i professionisti della governabilità, della manutenzione tecnica del sistema, privi di pensiero, perché il pensiero può essere un pericoloso fattore di turbamento dell’ordine costituito. Se la politica è prigioniera di questa impasse oscillando tra velleità e rinuncia, tra idee senza forza e forza senza idee, questo svuotamento della politica apre una crisi di prospettiva e di identità in tutto il tessuto sociale, e sembra oggi inverarsi totalmente il giudizio di Leopardi sullo “stato presente dei costumi degli italiani”. C’è un generale sfilacciamento dell’ordine sociale, una radicata diffidenza verso ogni sorta di progetto collettivo, e agisce quindi in profondità una forza corrosiva che mina dall’interno sia le forze politiche sia le grandi organizzazioni sociali. Su tutti i soggetti organizzati incombe la minaccia della burocratizzazione, dell’essere strutture senza vita e senza identità, incapaci di articolare in modo efficace e credibile il rapporto tra il mezzo e il fine, e incapaci quindi di produrre una mobilitazione consapevole.
Le due rappresentanze, quella politica e quella sociale, sono unite da uno stesso destino, l’una vive del rapporto con l’altra, e in una stagione di offuscamento delle identità, come è quella attuale, entrambe rischiano di imboccare la strada di un progressivo declino, più o meno accelerato. È la democrazia stessa, quindi, che viene aggredita nei suoi fondamenti, perché essa si regge sul pluralismo delle rappresentanze e sulla vitalità del loro confronto e del loro conflitto. La mia tesi è che questa prospettiva di una generale decadenza può essere evitata se i due campi del sociale e del politico si organizzano in un rapporto di totale autonomia, senza sovrapposizioni e senza improprie invadenze dell’un campo nell’altro. Ciò vuoi dire intraprendere una strada del tutto nuova rispetto alla nostra storia passata, che è la storia di un intreccio, talora assai stretto, talora più flessibile, stando comunque all’interno di un comune quadro teorico di riferimento, di una comune ispirazione ideologica, in base alla quale i due momenti del sociale e del politico sono solo le articolazioni di un unico processo. Nella storia della sinistra, ha funzionato come grande contenitore unificante il “movimento operaio”, l’idea cioè di un soggetto storico che racchiude in sé tutte le potenzialità progressive, per cui è la coscienza di classe la forza che muove la storia.
Ora, questa compattezza teorica si è del tutto dissolta, e tutto il processo in corso va nella direzione di una sempre più marcata sconnessione, per cui il politico e il sociale non sono le due forme di uno stesso processo, ma sono due processi del tutto distinti. Quale che sia il giudizio su questo tipo di evoluzione, questa è la realtà attuale di cui dobbiamo cogliere, in modo freddo e oggettivo, tutte le necessarie conseguenze. A questo punto, lo stesso concetto di “autonomia” appare insufficiente, e si configura piuttosto una sorta di “alterità”, un rapporto tra le due sfere non più nel segno della complementarietà, ma dell’esclusione e del conflitto. Se è così, è tutto il quadro che muta radicalmente, e si impone un modo del tutto nuovo di pensare e di agire. Questa alterità non ha, per me, il significato di un rifiuto della politica, e non ha nulla a che fare con tutta la campagna che si è orchestrata, in forme aggressive e qualunquistiche, non tanto contro i singoli abusi, ma contro l’idea stessa della politica, contro lutto ciò che va oltre l’immediatezza degli interessi, degli egoismi e delle passioni. Si tratta piuttosto di riconoscere che la politica ha un suo spazio, una sua sfera di azione, e che i soggetti sociali si muovono in una diversa dimensione, che insomma c’è un conflitto, fisiologico, democratico, e che il nostro sistema perde di forza e di vitalità se il conflitto non viene riconosciuto, se al pluralismo sociale si vuole sostituire il dominio esclusivo e incontrollato di un potere tecnocratico. Il conflitto, a sua volta, può essere governato e mediato, e per questo ha sempre tenuto aperto un canale di comunicazione e di confronto, che può produrre, ai diversi livelli istituzionali, accordi di concertazione.
D’altra parte, serve a poco la predica moralistica contro il populismo e contro l’antipolitica, su cui scarichiamo la nostra avversione pregiudiziale verso tutto ciò che suscita, a ragione o a torto, la nostra avversione. C’è, in questo atteggiamento, una sorta di aristocraticismo intellettuale, che riconosce come razionale solo il nostro particolare punto di vista, oltre il quale c’è solo il dominio dell’irrazionalità. Non c’è, nei fatti, questa separazione metafisica tra politica e antipolitica, ma ci sono diversi e opposti progetti politici, ciascuno dei quali va analizzato e giudicato nella sua concretezza.
La rappresentanza sindacale, in questo nuovo contesto, deve trovare in se stessa la sua identità e la sua forza espansiva. È questo un passaggio decisivo, che fin qui non è stato ancora compiuto, nell’attesa di possibili future evoluzioni del sistema politico, e continuando a rincorrere un possibile gioco di sponda, quando ormai dovrebbe essere chiaro che non ci sono sponde, non ci sono interlocutori privilegiati, ma c’è una dialettica sociale che deve potersi esprimere senza impacci e senza condizionamenti. L’effetto visibile di questa incertezza, di questa oscillazione tra autonomia e collateralismo, e quello di uno “slittamento nel politico”, per cui il modo di essere e di agire del sindacato finisce per ricalcare le forme della politica, e in effetti sono sempre più frequenti gli scambi, i passaggi dall’uno all’altro campo, accreditando così la tesi che il sindacato sia solo un anello del sistema di potere. Ora, anche per questa identità oscillante, il sindacato non è affatto messo al riparo dall’esplosione dell’attuale “crisi di sistema”, e ha davanti a sé il problema di una ridefinizione del proprio ruolo. Non basta la continuità dell’organizzazione, il suo rispecchiarsi in una storia gloriosa, non basta la manutenzione di una struttura collaudata, ma torna a imporsi con forza e con urgenza la domanda più radicale su quale sia l’orizzonte di senso che giustifica il sindacato come istituzione.
In una situazione di movimento, di radicalizzazione critica di tutti i processi, la scelta più imprudente è quella di una prudente e moderata conservazione dell’esistente, è l’affidarsi alla continuità, mentre tutto spinge per una rottura di tale continuità. Ciò non significa affatto rincorrere alla cieca lo spirito dei tempi, e volere il nuovo per il nuovo, ma ritrovare il filo conduttore di tutta la nostra storia e riscoprire l’attualità delle nostre ragioni di fondo.
A me sembra che al centro di tutta questa rivisitazione del ruolo del sindacato stia il tema dell’efficacia, della congruenza tra obiettivi e risultati, È un interrogativo che riguarda anche la politica, ma in modo diverso, perché la politica può lavorare sui tempi lunghi, e può agire come lenta maturazione di una forza, come accumulo di un potenziale di energia da spendere nel momento più favorevole, mentre per il sindacato l’efficacia si misura su tempi assai più ravvicinati. E nella situazione attuale è sempre più drammaticamente evidente lo stato di sofferenza del sindacato sotto il profilo dell’efficacia, della capacità di produrre risultati concreti. Da cosa dipende questo scarto? Da una scarsa combattività, o da una astrattezza velleitaria degli obiettivi, o da una incapacità di costruire le alleanze necessarie, o da un processo globale che fa saltare tutti i tradizionali punti di forza? Ci possono essere diverse risposte, tutte meritevoli di attenzione, ma è comunque importante partire da questa domanda, dalla quale dipendono tutte le prospettive del sindacalismo italiano, la sua destinazione nel mondo che cambia.
Nel concetto di efficacia si incrociano diversi temi, diverse piste di ricerca da esplorare. C’è anzitutto, come è evidente, l’analisi dei rapporti di forza, e qui ci troviamo nel mezzo di una grande tradizione politica, tutta costruita sul tema dell’egemonia e delle alleanze, della capacità di affermare la propria posizione “di parte” come l’espressione di un interesse generale. In questo lavoro di spostamento dei rapporti di forza va considerato come un elemento centrale e decisivo quello che si riferisce alla sfera delle idee, dell’interpretazione e della rappresentazione del mondo, perché si può vincere solo se di dispone di una solida base ideologica, di un punto di vista superiore, capace di integrare e di assorbire le molteplici parzialità degli interessi e delle culture. Questo aspetto non è affatto estraneo all’azione sindacale, perché anch’essa dipende dal contesto ideologico dominante, e tutta la storia in questi ultimi trent’anni è stata segnata dall’offensiva vittoriosa del pensiero liberista, e quindi dall’idea che eguaglianza vuol dire stagnazione, e diseguaglianza vuoi dire sviluppo. Se non esiste la società, ma esistono solo gli individui, il sindacato non può che essere il residuato storico di un’epoca ormai tramontata. A questo esito di spiazzamento definitivo dell’organizzazione sindacale lavorano non solo le culture di destra, ma anche, con una sotterranea convergenza, tutte quelle posizioni di sinistra che alla centralità del lavoro sostituiscono i diritti individuali della persona, che vedono dunque la libertà come quello spazio che si apre oltre il sociale, nel campo dei bisogni immateriali e della pura soggettività. Nel momento in cui il sindacato viene sfidato, nel suo stesso fondamento, deve saper reggere la sfida, e combattere la sua battaglia sul terreno culturale, per rendere nuovamente visibile la connessione tra lavoro e diritti, tra socialità e persona.
In secondo luogo, l’efficacia è la capacità di produrre consenso e mobilitazione, Gli obiettivi di una strategia di trasformazione non hanno valore per se stessi, ma solo in quanto intorno ad essi si organizza un movimento reale. E allora l’efficacia è strettamente connessa alla democratizzazione, perché è solo la partecipazione reale delle persone che può rendere concreto un determinato obiettivo, che può mettere in relazione la teoria e la pratica, il pensare e l’agire. Se i canali della democrazia sono ostruiti, è tutto il progetto politico che viene privato della sua forza espansiva. La burocratizzazione, quindi, non ha solo un effetto ritardante, ma ha come sua diretta conseguenza l’incapacità strutturale di ottenere qualsiasi risultato significativo. Come abbiamo già osservato, è il mezzo che si mangia il fine. E questo esito può essere evitato solo mettendo in campo una fortissima spinta partecipativa, evitando che tutto il processo si chiuda nell’autoconservazione di una qualche oligarchia dominante. La rivitalizzazione e la trasparenza del processo democratico sono oggi ancora più necessarie, perché non funzionano più i meccanismi dell’appartenenza, dell’identificazione ideologica e fiduciaria con l’organizzazione, e il rappresentante deve quotidianamente riconquistare il suo diritto a rappresentare, sottoponendo a verifica democratica tutte le sue scelte, tenendo sempre aperta la relazione, dall’alto e dal basso, con un movimento circolare che impedisca il cristallizzarsi di posizioni di potere. La rappresentanza non è altro che questa circolarità della relazione, ed entra in crisi, necessariamente, se alla relazione si sostituisce il comando, la decisione dall’alto.
Ma c’è da affrontare, infine, un punto più nevralgico e più decisivo, il quale dipende dall’idea stessa di efficacia. C’è un importante libro di François Jullien, Trattato dell’efficacia, nel quale sono messe a confronto la cultura greca e quella cinese, l’Occidente e l’Oriente, mettendo in evidenza due diversi approcci, due diverse concezioni della strategia politica. Basti ricordare la famosa formula paradossale di Sun Tsu, nell’Arte della guerra, per cui il grande stratega è quello che vince senza combattere, il che vuoi dire sfruttare tutto il potenziale di una determinata situazione, indirizzandolo e facendolo evolvere in una direzione favorevole, in modo che si può vincere non per una prova di forza, ma per una superiore intelligenza del corso delle cose. È il “non agire” del pensiero taoista, dove l’azione efficace è quella che si affida al processo naturale, alla sua evoluzione, senza forzarlo, senza l’irruzione violenta di una volontà che agisce dall’esterno. Si tratta di “giocare d’astuzia con la situazione”, lavorando sul suo potenziale, sull’equilibrio instabile delle forze che sono in campo, e sfruttando tutte le possibili risorse che la situazione stessa ci mette a disposizione. Come si vede, è l’esatto rovescio di tutta quella tradizione politica che mette al centro la decisione, l’atto di forza, la rottura rivoluzionaria, è la negazione del paradigma leninista del “primato della politica” nel quale molti di noi si sono formati, e nel quale, nonostante tutto, continuiamo a restare invischiati.
Ha qualcosa da dire anche a noi, uomini di un Occidente in crisi di identità, questo tipo di impostazione? Per un verso, ci troviamo in presenza di una teoria dell’opportunismo, dell’adattamento al corso delle cose, sfruttando passivamente tutte le occasioni che si possono presentare. Ed è questa una traiettoria sicuramente presente nella cultura cinese, nella sua idea di saggezza, nel suo modo di agire di traverso, di lato, senza mai entrare in uno scontro diretto, anche perché, in questa millenaria tradizione, non c’è spazio per la democrazia, per il conflitto visibile e riconosciuto, ma solo per la tattica di aggiramento e di condizionamento. Accade così l’attuale fenomeno straordinario di una Cina comunista e capitalista ad un tempo, che si sviluppa lungo una linea di ambiguità, di compromesso, di successivi e contorti aggiustamenti, senza che sia possibile un confronto aperto tra progetti alternativi. Non conta il conflitto delle idee, ma solo il risultato. Come dice Deng, non importa il colore del gatto, ma solo il fatto che sappia prendere i topi. E in questa caccia al topo, ovvero al risultato, la Cina attuale sta vincendo la sua sfida.
Ma in questa teoria dell’efficacia, così lontana dal nostro modo di pensare, c’è anche un nucleo di verità che a me sembra importante, e che ci può aiutare a districare i difficili nodi della nostra attuale condizione. In una fase di intenso e vorticoso mutamento, come possiamo far valere le nostre ragioni, i nostri valori di fondo, con una azione di resistenza, con uno scontro frontale, o mettendoci in gioco, dall’interno del processo, cercando di agire su tutte le potenzialità che la situazione concreta ci può offrire? In tutti questi anni, il sindacato è stato essenzialmente una forza di resistenza, e di testimonianza, conducendo una disperata battaglia difensiva. Questo vale soprattutto per la CGIL, mentre altri settori sindacali hanno semplicemente deciso di non resistere, e di adattarsi ai nuovi rapporti di potere, ritagliandosi un loro angusto spazio corporativo. È possibile uscire da questa stagione di resistenza, e agire dentro i processi reali, non per subirli passivamente ma per orientarli? È possibile un gioco di astuzia con la situazione? È questo tipo di discussione e di ricerca che andrebbe organizzato in vista del prossimo congresso della CGIL.
Sembra evitato il rischio di un congresso lacerante, di rottura, di contrapposizione, ma c’è anche il rischio opposto, di una navigazione troppo tranquilla in una linea di continuità, senza strappi e senza innovazioni, senza quindi fare davvero i conti fino in fondo con quella caduta dì efficacia che è il segno inquietante della nostra storia recente e della nostra attuale condizione. Senza uno scarto visibile nella direzione di marcia, sembra difficile scongiurare l’ipotesi di un declino dell’azione sindacale, di una sua progressiva marginalità. Per questo, dobbiamo mettere al centro della nostra riflessione quello che è il cuore dell’attuale fase di trasformazione: il lavoro, l’impresa, il modo in cui si sta riorganizzando tutto il rapporto tra capitale e lavoro. O il sindacato ha qualcosa da dire, e da fare, dentro la materialità di questo processo, o si adatta ad essere solo una struttura di servizio, che interviene sulle varie emergenze sociali, avendo ormai rinunciato a presidiare, con un proprio progetto, i luoghi strategici della produzione.
E’ qui che si misura l’efficacia, stando dentro i processi reali e dentro le loro contraddizioni. Potremmo così aggiornare la famosa tesi di Marx, dicendo che non basta voler cambiare il mondo, ma bisogna anzitutto conoscerlo nella sua dinamica e padroneggiare le tecniche da cui è regolato. Non si può essere una forza di cambiamento se non si dispone di tutto l’apparato conoscitivo necessario. C’è un dato paradossale: che l’impresa ha sempre più bisogno del contributo attivo e della responsabilità creativa dei lavoratori, perché ciò è richiesto dal nuovo livello delle tecnologie e dai più avanzati sistemi di organizzazione del lavoro; e che nel contempo si sta organizzando nel sistema delle imprese, a partire dalla Fiat, un modello del tutto autoritario, che schiaccia il lavoro in una posizione di totale subalternità, con un attacco sistematico a tutto il sistema dei diritti, individuali e collettivi. È possibile lavorare su questa contraddizione, e rimettere in campo un progetto di democrazia industriale, di partecipazione dei lavoratori alle decisioni? È possibile fare agire la stessa potenza tecnologica in una direzione diversa, come occasione di liberazione del lavoro anziché di suo asservimento? Per fare questo, dobbiamo spostare il baricentro dell’iniziativa sindacale nel luogo di lavoro, nell’impresa, là dove possono essere pensati e sperimentati nuovi modelli di organizzazione e di gestione, dobbiamo quindi mettere nel conto i possibili rischi dell’aziendalismo, nella convinzione che il sindacato deve stare sulla frontiera, là dove i processi avvengono, e non nelle retrovie.
Lo stesso discorso può essere fatto per il territorio, per le dinamiche dello sviluppo locale, per le possibili forme di concertazione, cercando di cogliere, anche in questo caso, tutte le opportunità, tutti gli spazi che si possono aprire a una iniziativa allargata del sindacato, con un approccio innovativo c sperimentale. Il sindacato si può costituire come un fondamentale presidio democratico del territorio, intervenendo sulle politiche di sviluppo, sulla regolazione del mercato del lavoro, sulle forme della sussidiarietà sociale, sui percorsi formativi, sull’intero tessuto connettivo in cui si organizza il sistema territoriale. Impresa e territorio, dunque, vanno visti nella loro connessione, come i due lati dello stesso processo, tenendo insieme i diritti del lavoro e i diritti di cittadinanza.
C’è un ultimo aspetto che a questo punto deve essere affrontato, e che costituisce la premessa indispensabile perché tutto questo lavoro di innovazione e di sperimentazione sia reso possibile. Si tratta della struttura organizzativa del sindacato. Se essa resta centralizzata, verticale, gerarchica, se il baricentro sta al vertice e non alla base, non sarà possibile nessuna significativa correzione, restando prigionieri di un meccanismo burocratico che ruota intorno a se stesso. C’è bisogno di una nuova generazione di quadri sindacali, i quali sappiano essere “sperimentatori sociali”, immersi nella materialità del lavoro che cambia e della società che si riorganizza, con un livello forte di autonomia, essendo misurati non sul criterio della fedeltà e dell’osservanza delle norme, ma su quello della creatività e della capacità di produrre risultati, facendo quindi dell’efficacia il nodo strategico su cui riorganizzare tutta l’azione sindacale.
Io credo che le stesse prospettive di unità tra le organizzazioni sindacali stanno in questa possibilità di una nuova iniziativa dal basso, di un concreto presidio democratico nell’impresa e nel territorio, là dove c’è un rapporto diretto con i lavoratori e con le loro domande, e dove hanno meno forza le logiche di contrapposizione identitaria e di conflitto tra le organizzazioni. È da questo lavoro di base che può venire, nel prossimo futuro, una ripresa dell’iniziativa sindacale unitaria, oggi bloccata da un gioco di vertice che ha motivazioni più politiche che sindacali, dentro quello slittamento nel politico di cui abbiamo parlato.
Ci sono le risorse umane per questa operazione? C’è nella società una domanda di partecipazione, di socialità, di organizzazione collettiva? E a questa scommessa che dobbiamo affidare le nostre prospettive, con un lavoro sistematico di scavo nel sociale, per fare emergere tutte le potenzialità della situazione. Non c’è la “fine del sociale”, ma un rapporto più complesso tra dimensione individuale e dimensione collettiva, con un accento più forte sulla soggettività, sui diritti, e sull’autonomia della persona. Ma questa nuova sensibilità può avere diversi sbocchi: può essere una regressione nel privato, ma può anche essere messa in movimento per una nuova stagione di mobilitazione democratica. E forse sta proprio qui, nella ricostruzione di un rapporto vitale tra l’io e il noi, tra l’individuale e il collettivo, la risposta possibile, per restituire efficacia e forza espansiva alla rappresentanza sociale.
Busta: 47
Estremi cronologici: 2013
Autore: Riccardo Terzi
Descrizione fisica: Volume, b/n, 408 pp.
Tipo: Scritti
Serie: Scritti Sindacali - SPI -
Pubblicazione: “Il sindacato nella crisi italiana”, Democrazia e diritto, n. 3-4, Franco Angeli, 2013, pp. 9-16

