IL SINDACATO E LA RIFORMA DELLA REPUBBLICA
Volume con uno scritto di Riccardo Terzi intitolato “Per una riforma del sindacato”
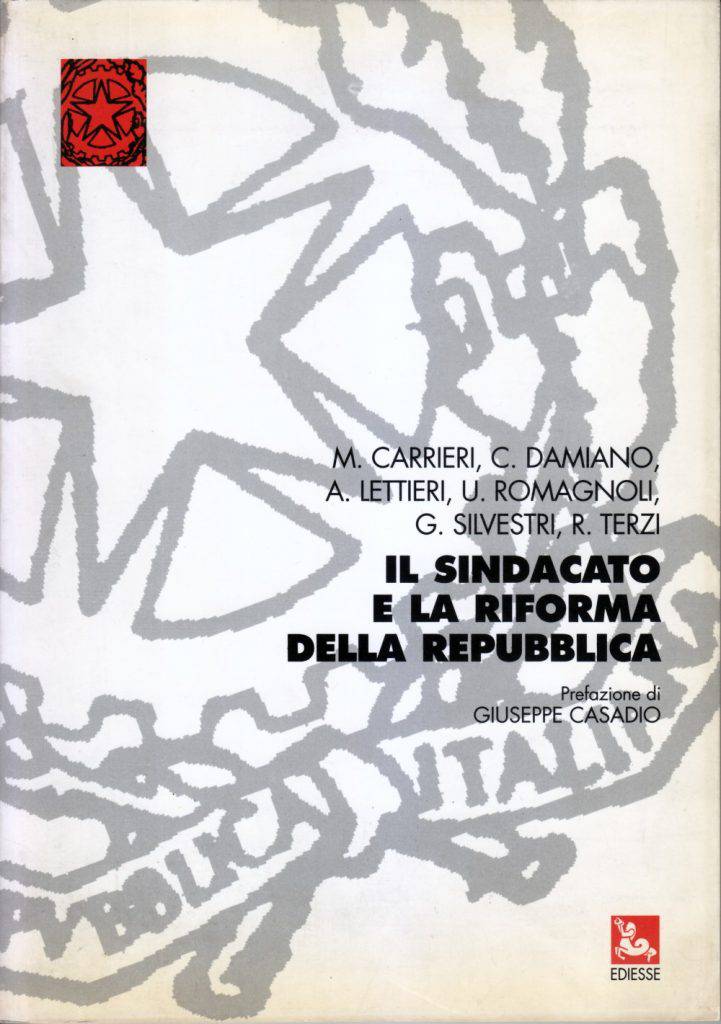 PER UNA RIFORMA DEL SINDACATO
PER UNA RIFORMA DEL SINDACATO
di Riccardo Terzi
Una sfida politica
Nella transizione italiana, che ha visto una progressiva decomposizione del sistema tradizionale dei partiti e una crisi di legittimità di tutti i poteri costituiti, il sindacalismo confederale appare come uno dei pochi punti di stabilità, in quanto il suo rapporto con la domanda sociale e la sua capacità di organizzazione e di rappresentazione degli interessi continuano a funzionare con un grado sufficiente di efficacia e di consenso.
Nel mezzo di una convulsione politica e istituzionale, segnata da elementi distruttivi e demagogici, il sindacato ha dato una prova di forza e di responsabilità. Le due tappe più significative da ricordare sono l’Accordo del luglio 1993, che sancisce il metodo della concertazione e fissa le regole di un nuovo sistema contrattuale, e la grande mobilitazione di massa sul tema delle pensioni, che alla fine si è concretizzata in un primo importante accordo per la riforma e la riorganizzazione dello Stato sociale.
In questa combinazione intelligente di mobilitazione e di esercizio di responsabilità, si esprime in modo esemplare il possibile ruolo del sindacato nella società moderna, in quanto soggetto sociale che si misura con i grandi temi della trasformazione della società italiana, e che assume per questo una sua piena legittimazione istituzionale. Non si tratta di una parentesi, di un’azione di supplenza politica che in via eccezionale si è resa necessaria, ma del nucleo centrale di una possibile strategia. Per questa via il movimento sindacale può qualificare la sua azione costruendo una propria autonoma capacità di progetto e cercando di incidere, in un confronto aperto con le controparti sociali e con gli interlocutori istituzionali, sulle grandi scelte strategiche che debbono guidare il processo di modernizzazione del Paese.
Di ciò non c’è ancora una piena consapevolezza, e una parte dei gruppi dirigenti del sindacato sembra ricercare la via di una più tranquilla ritirata nel tradizionale spazio contrattuale e rivendicativo. Ma è la stessa forza oggettiva dei processi reali a spingere il sindacato verso una nuova dimensione politica, perché in realtà la via della ritirata è ormai preclusa. Su tutti i terreni, dall’occupazione ai diritti sociali, dall’impresa al territorio, il sindacato si trova necessariamente ad incrociare la politica, e scopre di trovarsi nel mezzo di un sistema di interrelazioni nel quale non c’è più una visibile linea di confine tra il sociale e il politico. Non c’è più quindi un luogo protetto dove ritirarsi, non c’è altra possibilità che quella di misurarsi in campo aperto sui problemi complessivi della società italiana.
In una società fortemente integrata, in un’economia a dimensione mondiale, qualsiasi obiettivo, anche parziale, chiama in causa l’equilibrio complessivo, e quindi la dimensione politica.
Il sindacato è sfidato dai nuovi processi, e si tratta di una sfida politica. Si rende quindi necessario un impegno di più vasto raggio, per cercare di affrontare i problemi sociali nella loro radice, nel loro fondamento.
Dopo la formazione del nuovo governo di centro sinistra, il sindacato è rimasto sostanzialmente coerente con questa impostazione e ha dimostrato una sua forte capacità di autonomia, stringendo con il governo un confronto di merito molto serrato, sulle politiche per il lavoro, sulla legge finanziaria, sul fisco, sulla politica dei redditi, senza nessun atteggiamento di sudditanza rispetto al nuovo quadro politico. Ciò è molto importante, perché sgombra il campo da possibili sospetti di strumentalità politica. Da Berlusconi a Dini, a Prodi, la bussola del sindacato non cambia. Solo così il movimento sindacale può avere credibilità e consenso, perché interpreta con coerenza la sua specifica funzione di rappresentanza sociale, in un rapporto di autonomia rispetto all’intero sistema politico e istituzionale.
Se dunque il sindacato non è stato investito dalla crisi, ciò è il risultato di alcune precise scelte politiche, che non erano affatto scontate, e anzi sono state assunte dentro un processo travagliato e contrastato. Da un lato, c’è la spinta verso una linea di opposizione sociale permanente, che rifiuta qualsiasi assunzione di responsabilità politica e si riduce pertanto ad un’azione di resistenza e di difesa passiva degli interessi, subendo così il condizionamento di tutte le spinte corporative. Se fosse prevalsa questa posizione, il sindacato sarebbe stato spinto verso uno scontro frontale, e sarebbe stato travolto. Dall’altro lato, c’è la continua insidia di comportamenti e di valutazioni che discendono da una logica di appartenenza politica, e che mettono quindi a rischio l’autonomia del sindacato. Questo rischio si accentua nel momento in cui le forze politiche della sinistra hanno una responsabilità di governo, e può scattare un meccanismo di condizionamento psicologico, di subalternità culturale, provocando così effetti di snaturamento delle ragioni e delle motivazioni autonome del sindacato.
Finora si sono evitati questi due opposti pericoli, ma la partita è tuttora aperta e la navigazione resta assai rischiosa.
L’offensiva restauratrice e i referendum di Pannella
Quale ruolo potrà avere il sindacato nel nuovo sistema politico e istituzionale che si sta delineando? Quale sarà dunque il contenuto sociale del nuovo processo costituente? È un interrogativo tutto aperto, e occorre tener conto, per tentare una risposta, di molte variabili e di una complessa dinamica delle forze. Il giudizio positivo sulla capacità che ha avuto il movimento sindacale, in questa fase di convulsa transizione politica, di far valere il proprio ruolo e la propria autonomia non rappresenta in nessun modo una garanzia per il futuro. Sarebbe questo un drammatico errore di valutazione.
Nel momento in cui è aperto uno scontro per la ridefinizione dei rapporti di forza e di potere nella società, nel momento in cui tutti gli equilibri, istituzionali e sociali, sono rimessi in discussione, è chiaro che anche il sindacato è coinvolto in questo processo e che non ci sono più rendite di posizione garantite. I segni di una controffensiva antisindacale sono già evidenti. È in atto, in modo dispiegato, un attacco ai più significativi risultati che il sindacato ha conseguito negli ultimi anni, dal sistema contrattuale alla riforma pensionistica. E soprattutto viene contestata la funzione “generale” del sindacato, nel nome di un ripristino del primato della politica e di una riaffermazione astratta della sovranità delle istituzioni.
L’attuale ruolo del sindacato, come soggetto politico forte, come interlocutore riconosciuto e legittimato, come attore istituzionale, è da più parti considerato come un’anomalia da rimuovere, come un residuo di consociativismo da Prima Repubblica, e in questo senso il progetto di riforma istituzionale è pensato essenzialmente, come il conferimento all’esecutivo di un’investitura popolare e plebiscitaria che consenta al governo di esercitare i suoi poteri decisionali senza i vincoli e senza i condizionamenti della mediazione sociale. Tutte le forze politiche, senza una significativa differenziazione tra la destra e la sinistra, identificano il tema delle riforme istituzionali con la costruzione di un esecutivo forte, nel quale si ripristina il primato della politica. Il deficit della società italiana, secondo questa impostazione, è un deficit di autorità, di potere decisionale, e quindi il sistema politico va semplificato e alleggerito dal peso eccessivo delle procedure che richiedono partecipazione e consenso.
Di fronte ai difficili problemi di regolazione di una società complessa, ci si illude che possa ancora una volta funzionare la ricetta classica del rafforzamento dei poteri del principe, prescindendo dall’analisi della realtà, dal pluralismo reale di poteri, di sedi decisionali, di soggetti, nei quali si articola la società moderna. Nella logica della “democrazia maggioritaria”, la quale si fonda sul modello astratto di un processo di legittimazione che va direttamente dai cittadini alla leadership di governo, tutte le strutture di mediazione vengono considerate come un ostacolo sul cammino della riforma: i partiti, il sindacato, il Parlamento, gli organismi autonomi di garanzia.
Si tratta di una rappresentazione tutta ideologica, perché la realtà dei processi politici segue percorsi ben altrimenti complessi. Ma i fantasmi ideologici, quando diventano senso comune, cultura di massa, provocano effetti reali, in quanto orientano i comportamenti di fatto delle persone e dei soggetti sociali. L’effetto di questa temperie ideologica oggi dominante, di questa idealizzazione demagogica della “democrazia dei cittadini”, consiste in un processo di rottura dei princìpi fondanti del nostro ordinamento costituzionale, per il quale i diritti del singolo sono inseparabili dalle “formazioni sociali ove si svolge la sua personalità”, e quindi la vitalità della democrazia è la vitalità dei corpi sociali, delle strutture di rappresentanza, in assenza delle quali il singolo cittadino è solo una pedina impotente, manipolata da forze oggettive che la sovrastano.
Si tratta di un attacco alla vocazione sociale della Costituzione, ai suoi elementi più innovativi e progressivi, per tornare al vecchio modello della democrazia liberale, all’universalismo astratto dei diritti e alla finzione di una uguaglianza giuridica che non si occupa delle condizioni sociali concrete dalle quali dipende l’effettività dei diritti fondamentali.
Il tema delle riforme istituzionali non è, quindi, un tema neutro dal punto di vista sociale, ma è il terreno di una competizione aperta a diversi possibili equilibri. Finora nel dibattito politico questa complessa significazione sociale del progetto costituzionale è rimasta nell’ombra, e tutta la discussione sembra limitarsi ai meccanismi tecnici di legittimazione e di stabilizzazione della funzione di governo. Anche a sinistra si parla lo stesso linguaggio, si resta dentro un orizzonte giuridico-formale, e in tale contesto la “governabilità” appare come l’unico obiettivo, come se si trattasse solo di un problema tecnico e non politico-sociale.
Per questo, il futuro appare assai incerto, e il processo di riforma, se non viene riqualificato nei suoi obiettivi, può avere effetti devastanti, nel senso di una ulteriore lacerazione del rapporto tra politica e società: la politica punta a riprendere il suo primato in una logica di dominio, di comando gerarchico, la quale prescinde dalle esigenze di coesione e di articolazione sociale. Ma è, a questo punto, una politica svuotata, ridotta agli interessi di un ceto politico ristretto e separato dalla società.
Si determina così un’azione a tenaglia tra una concezione individualistica della democrazia e una possibile pratica di governo oligarchico: l’astrattezza demagogica del popolo e la concretezza del dominio. In questa tenaglia tutti i corpi sociali intermedi finiscono per essere schiacciati. Se il modello istituzionale consiste nell’investitura popolare della leadership di governo, tutto ciò che sta nel mezzo (sindacati, associazionismo, rappresentanze) è solo un ostacolo, un’ingerenza, e va quindi drasticamente ridimensionato.
Si tratta probabilmente di un’operazione velleitaria, perché il pluralismo dei poteri e dei soggetti sociali è inscritto nella Costituzione materiale del paese. Ma intanto si è aperta, anche in forme violente, una fase di conflittualità, di scontro istituzionale, e particolarmente significativo e inquietante è il conflitto tra politica e magistratura, al culmine di un processo nel quale la magistratura ha saputo finalmente svolgere le proprie funzioni costituzionali di autonomia e di controllo della legalità. Il conflitto in atto, nella sua sostanza, non può essere spiegato se non come il tentativo estremo di riaffermare non già il primato della politica, ma la condizione di irresponsabilità del ceto politico, riconducendo l’azione giudiziaria nell’alveo tradizionale di un’autonomia controllata.
E il sindacato? In questo contesto, se e fino a quando la cultura politica dominante ha questi tratti plebiscitario-oligarchici, il sindacato non può che essere il bersaglio di una offensiva restauratrice. L’offensiva è stata aperta dai referendum di Pannella, e il loro esito, per molti aspetti preoccupante, dimostra come il terreno di questa offensiva sia tutt’altro che infecondo. Il sindacato si è difeso male, con impacciò, con divisioni interne, e non ha saputo prospettare soluzioni forti e convincenti ai problemi di democrazia e di trasparenza che nei referendum erano contenuti.
Ecco il punto: per reggere questa offensiva, è necessario un progetto di riforma del sindacato. È necessaria un’operazione di verità che metta in chiaro la situazione attuale del sindacato, i suoi punti di debolezza, le sue strozzature burocratiche, le sue ambiguità, e che indichi un progetto chiaro e credibile per il futuro. In assenza di ciò, il sindacato finisce per essere in balìa della contingenza politica, del gioco delle forze e delle convenienze. E l’apparente forza attuale può rapidamente dar luogo ad un processo di marginalizzazione. Il momento di questo passaggio mi sembra non essere lontano. Oggi il sindacato approfitta di un quadro politico non ancora assestato, con elementi di precarietà non risolti, ma è una condizione contingente, e le tendenze di fondo che guidano il processo politico fanno pensare ad un prossimo conflitto nella definizione delle rispettive sfere di competenza. Questo conflitto è già oggi latente, e può esplodere alla prima occasione.
Un’operazione di verità e un progetto di riforma: ciò è oggi indispensabile, ma si tratta di un processo assai difficile, perché pesa la forza di inerzia che è propria di tutte le grandi organizzazioni e che fa ostacolo a qualsiasi iniziativa di innovazione, pesa l’intreccio di convenienze e di posizioni di potere acquisite che contrasta con l’esigenza di un dibattito trasparente. Occorre per questo, per non restare invischiati nella ragnatela burocratica, una iniziativa politica con la quale aprire una discussione chiara ed esplicita su un possibile progetto di rinnovamento del sindacato. Non c’è, a mio giudizio, molto tempo a disposizione, e il protrarsi dell’attuale situazione, tutta giocata sull’immediato, sulla tattica, con un dibattito interno gelatinoso e diplomatico, che non scioglie con chiarezza nessuno dei nodi politici aperti, tutto ciò può far precipitare la crisi.
Non è più possibile una soluzione del problema dall’esterno, per via politica, come è accaduto più volte nel passato. Il rapporto tra sindacato e sinistra politica si presenta oggi in termini del tutto nuovi, più problematici e più difficili, e viene meno quella sostanziale convergenza che ha configurato nel passato la storia del movimento operaio come una storia unitaria, comune, nella quale il piano sindacale e quello politico erano strettamente intrecciati.
La sinistra politica si muove in una prospettiva più ampia, superando qualsiasi connotazione di classe, e quindi i problemi della rappresentanza sociale pesano tutti esclusivamente sulla responsabilità dell’organizzazione sindacale, che non può delegare a nessuno il proprio ruolo e che non può contare su un sistema predefinito di alleanze e di collateralismi. Fa eccezione, in questo nuovo quadro politico, il tentativo di Rifondazione Comunista, che punta ad una sua diretta espressione organizzata dentro il sindacato, ma si tratta solo di un’operazione fuori tempo, la quale non può produrre che una: piccola nicchia, un piccolo gruppo di pressione, senza forza espansiva. L’autonomia è oggi un tratto fondante del sindacato. La sopravvivenza di logiche partitiche è appunto solo una sopravvivenza, che non genera nulla di nuovo e di vitale.
La piena affermazione dell’autonomia del sindacato rispetto al sistema politico, preso nella sua globalità, è un punto d’approdo essenziale, ed è il punto da cui ripartire per costruire un progetto sindacale adeguato ai tempi. Il sindacato è il titolare esclusivo delle funzioni di rappresentanza sociale, e deve perciò costituirsi come soggetto autonomo e indipendente. In questo movimento è implicito un conflitto potenziale, un elemento di tensione, una dialettica sempre aperta tra sindacato e sfera politica. Ed è solo assumendo senza subalternità questo possibile terreno di conflitto che il sindacato si afferma come soggetto politico e apre la possibilità di un proprio rilancio.
La tendenziale evoluzione verso un sistema bipolare non muta questo quadro, perché non c’è più una corrispondenza visibile tra aggregazioni politiche e processi sociali, e un sindacato che si lasciasse inglobare in una logica di schieramento finirebbe per perdere la sua stessa ragion d’essere, il suo ruolo costitutivo di forza rappresentativa del mondo del lavoro.
Il ruolo politico-istituzionale del sindacato
Nel momento in cui è aperto il problema di un nuovo assetto istituzionale, di un ridisegno dei poteri e delle procedure decisionali, il primo quesito che si pone per il sindacato riguarda la sua collocazione dentro il nuovo sistema che si viene organizzando. E la domanda, fin qui elusa, è la seguente: il sindacato ha un ruolo istituzionale, è un attore riconosciuto e legittimato nel processo di produzione delle decisioni politiche?
Rispondere con chiarezza a questa domanda è molto importante perché la risposta è carica di conseguenze e di implicazioni, e la mia risposta è assolutamente positiva. Il sindacato è una necessaria articolazione del sistema istituzionale. Affermare questo ruolo è il modo concreto di contrastare le tendenze plebiscitario-oligarchiche, per le quali l’esercizio del potere politico è esclusivamente legittimato dal mandato popolare, e una volta ottenuto questo mandato non c’è nessun momento ulteriore di costruzione del consenso e non ci sono rappresentanze sociali legittimate a confrontarsi con l’esecutivo e a produrre decisioni politiche. Nella logica della “semplificazione autoritaria” del potere, il sindacato non può avere spazio, e non ci possono essere corpi sociali intermedi che agiscano come soggetti politici, perché tutto lo spazio politico è sequestrato dal processo di investitura democratico-plebiscitaria del leader.
La scelta di un sindacato “istituzionale”, soggetto politico che entra a pieno titolo nel circuito delle decisioni politiche, non ha quindi il senso di una “omologazione”, di un adattamento all’esistente, di una perdita di autonomia, ma al contrario significa dare forza e autorevolezza alle grandi organizzazioni sociali, contrastando le tendenze verso una democrazia di stampo esclusivamente liberale.
Naturalmente, tutto il discorso che viene qui fatto per il sindacato vale, nella stessa misura, per tutte le rappresentanze sociali e per le diverse forme di associazione in cui si organizza la società civile. Il problema del sindacato è solo un capitolo del problema più generale che riguarda i rapporti tra società politica e società civile. Si tratta di decidere se queste due sfere devono restare separate, se la politica dunque si costituisce come struttura autosufficiente e autoreferenziale, o se viceversa la democrazia deve continuamente essere vivificata dall’incontro delle due sfere, da una politica che si apre alle domande sociali e da soggetti sociali che, superando la dimensione corporativa, si interrogano sull’interesse generale e si misurano con la politica.
Ciò significa, per il sindacato, costruire un movimento complesso dall’immediatezza degli interessi verso una proposta politica di sintesi, significa quindi superare gli elementi di spontaneità e ricomprendere la pluralità discorde degli interessi in un progetto politico. In ciò appunto consiste il carattere di “confederalità” che già il movimento sindacale ha saputo elaborare e realizzare, e la confederalità è già in se stessa un momento di elaborazione politica, un superamento dell’immediatezza. Si tratta quindi solo di rendere questa scelta, già implicita nell’esperienza reale, più matura e conseguente, e di trame tutte le implicazioni necessarie.
A ciò si oppongono le concezioni movimentistiche, per le quali il sindacato è solo una struttura di servizio, a supporto di tutte le spinte rivendicative, indipendentemente dal loro contenuto e dalla loro compatibilità. L’obiettivo si esaurisce nell’esercizio del conflitto sociale, e sarà il conflitto, nel suo movimento spontaneo, a produrre nuovi equilibri e a determinare gli sbocchi politici. Ma è evidente che in questo caso la politica ha tutto il diritto di affermare il suo primato e la sua autosufficienza, perché oppone alla segmentazione degli interessi la sua capacità di sintesi.
Nella realtà, quindi, le forme corporative e movimentiste del sindacato finiscono per essere inevitabilmente subalterne, perché rinunciano in partenza alla dimensione politica e ribadiscono così la separatezza e l’autosufficienza di un sistema politico la cui legittimazione sta altrove, e che perciò non ha bisogno di stabilire con le rappresentanze sociali un momento organico di confronto. I due piani restano nettamente distinti, separati, e l’azione sindacale, per quanto possa essere fortemente conflittuale, non ha peso politico, ma agisce solo come fattore di disturbo, come elemento di pressione, affidandosi esclusivamente alla contingenza dei rapporti di forza. Per questa via il sindacato finisce per essere estromesso da tutte le sedi decisionali davvero impegnative, e finisce quindi per subire gli effetti di decisioni che vengono prese altrove, fuori dalla sua portata.
Il sindacato – questa è la conclusione – ha un peso solo se e in quanto assume esplicitamente una dimensione politica e riconosce il suo ruolo istituzionale, proponendo in questo senso l’adozione di un preciso modello di relazioni tra il potere politico, ai diversi livelli, e le forze sociali. È la via della concertazione, che ha avuto finora il suo momento più avanzato di realizzazione nell’Accordo con il Governo Ciampi, e che però presenta ancora molti elementi di incertezza, di precarietà, come dimostra tutta la storia recente delle relazioni sindacali, che solo in parte si è mossa in coerenza con quel modello di concertazione.
Bisogna ripartire da lì, e fissare regole più vincolanti, procedure più certe, un quadro chiaro di responsabilità, di ruoli e di competenze, entro il quale il sindacato possa esercitare la sua funzione essenziale di rappresentanza sociale del lavoro. La concertazione è una procedura formalizzata di confronto, che impegna i diversi soggetti ad intese vincolanti e a comportamenti coerenti. Finora in Italia è mancata, sui diversi fronti, una vera cultura della concertazione, perché da un lato si è puntato solo ad un obiettivo di neutralizzazione subalterna del sindacato, e dall’altro lato resta assai forte la diffidenza sindacale verso intese politiche impegnative, viste come un elemento di condizionamento e non come un’occasione positiva di affermazione del proprio ruolo.
Il risultato è che ogni intesa dà luogo ad un gioco di interpretazioni, di furbizie, di elusione degli impegni, e resta quindi un quadro di conflittualità strutturale e di inaffidabilità reciproca. Ma questa resta la strada su cui scommettere per il futuro, perché non c’è nessuna alternativa realisticamente praticabile. La concertazione è il riconoscimento del ruolo politico del sindacato. Il fallimento della concertazione, che qualcuno a sinistra auspica in quanto apertura di una fase di autonomia e di rilancio del conflitto sociale, avrebbe solo l’effetto di costringere il sindacato ai margini delle decisioni politiche e di rinchiuderlo in un’azione meramente difensiva.
Regolazione legislativa della rappresentanza
L’assunzione di un ruolo istituzionale da parte del sindacato, in quanto attore riconosciuto del processo di concertazione, comporta una precisa e rilevantissima conseguenza sotto il profilo delle regole di democrazia che debbono qualificare l’azione del sindacato, le sue procedure decisionali, le forme della rappresentanza. Se il sindacato è un soggetto politico legittimato, la sua vita interna non è più un affare privato, ma un affare pubblico. La sua legittimazione democratica deve essere verificata e regolata, perché solo a questa condizione l’accesso alle decisioni politiche ha una sua giustificazione, perché appunto non si tratta di un fatto associativo incidentale, ma di un soggetto democratico effettivamente rappresentativo del mondo del lavoro.
Occorre necessariamente ritornare all’ispirazione del dettato costituzionale, ovvero a un rapporto certificato di corrispondenza reale tra rappresentatività e potere contrattuale, superando l’attuale stato di arbitrio, di precarietà dei processi che regolano la rappresentanza sindacale. Una soluzione legislativa è assolutamente necessaria, ed è un compito urgente per fissare finalmente un sistema chiaro di ‘regole, di diritti, di garanzie per i lavoratori. Abbiamo ora solo un’intesa pattizia per l’elezione delle RSU, che in quanto pattizia viene applicata solo là dove l’accordo funziona, e lascia un vastissimo territorio grigio privo di regole e di rappresentanze democratiche, e abbiamo ancora una legislazione – lo Statuto dei diritti dei lavoratori – che si era formata in tutt’altra situazione storica e che oggi non funziona più come efficace strumento di regolazione.
A ciò si aggiungono gli effetti dei referendum, che hanno aperto un ulteriore vuoto normativo, col risultato di determinare una situazione che è lasciata in balìa dei movimenti di fatto e delle convenienze dei diversi attori, con tutti i rischi di frammentazione aziendalistica e di arbitrio nelle relazioni contrattuali. È ora di tornare al principio costituzionale: il potere contrattuale è legato alla verifica democratica del consenso, all’effettiva rappresentatività delle organizzazioni sindacali. E questa esigenza è tanto più stringente quanto più si afferma un metodo di concertazione che assegna alle organizzazioni sociali un ruolo nel circuito delle decisioni politiche.
La scelta, che fin qui è stata compiuta, a favore di una regolazione solo contrattuale e non legislativa, non regge più e va esplicitamente abbandonata.
Il permanere di questa opzione contrattualistica costituisce ormai un punto di debolezza, di precarietà, in quanto alle organizzazioni sindacali vengono poste, dalla coscienza democratica e civile del paese, alcune precise domande non più eludibili.
Su che cosa si fonda la loro legittimazione, da chi hanno ricevuto un mandato, quali garanzie offrono sul piano della rappresentatività? Ed è interesse vitale del sindacato il rafforzamento del suo rapporto democratico con i lavoratori, perché da questo rapporto esso trae forza e prestigio. Nel confronto politico con il governo e con le controparti sociali la risorsa democratica, ovvero il consenso attivo dei rappresentati, è un punto di forza assolutamente decisivo e insostituibile, in assenza del quale tutta la situazione finisce per giocare a sfavore del sindacato e del suo potere contrattuale. L’idea, dunque, che le procedure democratiche siano un impaccio, una menomazione della responsabilità dei gruppi dirigenti, una concessione all’estremismo movimentista, è una totale assurdità, ed è il sintomo di una grave distorsione, dirigistica e autoritaria.
La costruzione di un sistema di regole democratiche è un’operazione complessa, perché occorre equilibrare diversi aspetti: la democrazia associativa, che riguarda il rapporto con gli iscritti, la democrazia rappresentativa, che riguarda gli organi di rappresentanza eletti da tutti i lavoratori, la democrazia diretta, che riguarda l’uso di procedure di tipo referendario. Nella combinazione tra questi diversi aspetti ci può essere un ventaglio assai ampio di soluzioni, e io credo che soprattutto si debba rafforzare il momento rappresentativo, per evitare sia l’unilateralità delle decisioni di organizzazione sia il rischio di un continuo ricorso referendario, che è in quanto tale esposto a manipolazioni di varia natura, interne ed esterne. Una forte rete di rappresentanze legittimate democraticamente, nell’azienda e nel territorio, può essere la struttura portante di una pratica sindacale che rende sistematicamente conto ai lavoratori dei propri obiettivi e dei propri risultati.
Si apre qui una curiosa contraddizione all’interno del movimento sindacale, perché di queste due esigenze tra loro così strettamente intrecciate, il ruolo politico-istituzionale del sindacato e la trasparenza dei suoi processi democratici, la CGIL e la CISL sembrano vedere solo un lato del problema, e si accaniscono così in una contrapposizione che non ha alcuna ragion d’essere, proprio perché solo nell’unità di questi due aspetti si costruisce una strategia sindacale efficace e aperta al futuro.
Non si capisce infatti come un sindacato che sia solo “associazione privata”, senza obblighi giuridici, possa avere i titoli necessari per partecipare alle decisioni politiche, e d’altra parte sono altrettanto poco comprensibili la prudenza e la riluttanza della CGIL ad assumere fino in fondo, con chiarezza, il modello di una democrazia della concertazione. Queste due unilateralità, finché restano tali e tra loro contrapposte, impediscono la definizione di un progetto forte, convincente, e si trascina così una divisione che ha solo l’effetto, a questo punto, di rendere tutto il movimento sindacale più fragile, esposto all’offensiva conservatrice in atto senza aver preparato una strategia di risposta.
La divisione del movimento sindacale, nel momento in cui sono definitivamente cadute le ragioni storiche e ideologiche che l’hanno generata, è solo il frutto di una forza d’inerzia, di una pigrizia mentale, di un attaccamento a identità ormai sorpassate, di una logica di sopravvivenza burocratica che finisce per prevalere sulla necessità di un’elaborazione strategica adeguata alle nuove condizioni. L’unità si costruisce su una proposta di sintesi che supera le singole unilateralità, i simboli ormai consunti delle rispettive identità di organizzazione. E la sintesi sta nell’intreccio consapevole di ruolo politico e di trasparenza democratica, nel riconoscersi come un soggetto politico, istituzionalmente legittimato e responsabile, che è titolare di diritti nella stessa misura in cui si vincola al rispetto di precisi doveri democratici, garantendo così un processo reale nel quale sono, in ultima istanza, i lavoratori a conquistare voce politica e diritto di cittadinanza.
Federalismo: una scelta strategica
Il processo istituzionale in corso ha come suo possibile elemento di innovazione la rottura del vecchio centralismo statale e l’esplorazione di nuovi modelli di tipo federalista. Non lasciamoci ingannare dall’apparente unanimismo intorno al tema del federalismo, perché nella realtà qualsiasi atto significativo di riforma e di innovazione richiederà uno scontro assai aspro, e già sono mobilitati i numerosi gruppi di interesse che puntano, in sostanza, ad un fallimento del disegno di riforma. La riforma dello Stato non sarà un cammino agevole, ma il terreno di un durissimo scontro politico.
E il federalismo, se vogliamo dare a questo termine il suo vero significato di rottura, significa un rovesciamento degli schemi politici e culturali del passato, in quanto alla logica dell’uniformità si sostituisce il riconoscimento e la valorizzazione delle differenze territoriali. L’unità nazionale non è il punto di partenza, ma è solo il risultato di un processo, nel quale i soggetti portanti sono i sistemi di autogoverno. Il federalismo è una unificazione dal basso, a partire dalle differenze, a partire dalla specificità dei sistemi locali.
Cambia, dunque, la forma dello Stato, e conseguentemente si debbono riorganizzare tutte le forme dell’azione politica, cogliendo la specificità delle diverse situazioni, sperimentando soluzioni differenziate, costruendo nel territorio le condizioni di funzionamento di un “sistema” sociale ed economico.
Il sindacato deve decidere se impegnarsi in questo processo, in questa battaglia politica che sarà nel prossimo futuro il terreno fondamentale su cui si misura l’effettiva volontà riformatrice dei diversi soggetti, politici e sociali. Finora c’è solo un’apertura astratta al tema del federalismo, ma nessuna vera innovazione coerente e nessun impegno pratico che segni davvero una rottura con i modelli di centralizzazione. Il federalismo è stato ammesso nel lessico del sindacato, ma non ancora nella sua pratica reale.
Il tema è importante e decisivo, perché non c’è federalismo se non si riorganizza su nuove basi il sistema sociale, se non cambia il modello delle relazioni, se non si costruiscono cioè “sistemi territoriali”, con un investimento strategico di tutti i diversi soggetti nella direzione dell’autogoverno locale.
I cambiamenti di carattere istituzionale rappresentano, di per sé, solo l’involucro, la cornice, ed essi saranno produttivi solo se si riorganizza la società civile, se dentro questo involucro agiscono le forze reali della società. Il sindacato non è affatto estraneo a questa tematica, ma è anzi un attore determinante. E finora il sindacato ha agito esclusivamente sulla base di un modello di centralizzazione, partendo dall’assunto teorico che solo un forte potere centrale può garantire i diritti di tutti e realizzare il principio costituzionale di eguaglianza e di universalità dei diritti sociali. In questo senso il sindacato è stato un alleato del centralismo statale, e anche i suoi comportamenti attuali, nonostante qualche superficiale cambiamento di linguaggio, continuano ad agire nella logica tradizionale.
Occorre dunque un chiarimento di fondo, che definisca il ruolo che il sindacato intende svolgere sul tema oggi cruciale della riforma dello Stato. Il federalismo è l’asse obbligato della riforma, ed esso significa riprogettare, su basi del tutto nuove, le forme dell’amministrazione e gli strumenti della regolazione politica. È una scelta strategica che richiede da parte di tutti un nuovo tipo di orientamento e una forte tensione innovativa. Il sindacato deve scegliere, con la necessaria chiarezza, se partecipare a questo progetto, ·se qualificarsi come un attore del cambiamento istituzionale, o se viceversa attestarsi nella difesa del modello tradizionale, nel timore che l’attivazione di un processo di autonomia dei sistemi territoriali possa disarticolare il sistema delle tutele e produrre situazioni non accettabili di diseguaglianza.
Si tratta cioè di decidere se assumere il terreno dell’autonomia e dell’autogoverno come una possibile risorsa per un nuovo sviluppo democratico del paese e per una più efficace organizzazione di tutta la struttura amministrativa dello Stato. Questa è la sfida del federalismo: essa presuppone che solo nella concretezza delle diverse situazioni si possono trovare le risposte, le soluzioni efficaci, e si può ristabilire una corrispondenza, una comunicazione funzionale tra la società e le istituzioni. Il federalismo è il tentativo di ricomporre il rapporto tra politica e società, nella cui divaricazione stanno le ragioni profonde della crisi attuale. Ciò non riguarda solo lo Stato, ma anche il ruolo delle grandi organizzazioni politiche e sociali, che hanno in molti casi perso la capacità di un rapporto vivo con la realtà, di un radicamento sociale effettivo.
Anche il sindacato, dunque, ha la necessità di una nuova comunicazione con la domanda sociale, e ha bisogno per questo di articolare la sua iniziativa, con una strumentazione flessibile che si adatti ai diversi contesti sociali e territoriali. Pensiamo, ad esempio, ai problemi del mercato del lavoro, della formazione, delle politiche di sviluppo, dell’ambiente, i quali richiedono, con tutta evidenza, risposte differenziate. Fino a che si resta dentro un modello centralizzato, e fino a che la struttura dell’amministrazione è organizzata nelle forme rigide e burocratiche che sono proprie del centralismo ministeriale, non si afferra la concretezza differenziata delle situazioni e si impostano inevitabilmente strategie inefficaci.
La supposta corrispondenza tra centralismo ed eguaglianza dei diritti si dimostra, alla prova dei fatti, del tutto fallace, perché l’inefficacia dell’azione politica e il cattivo funzionamento dell’amministrazione provocano condizioni crescenti di ineguaglianza. L’ineguaglianza dei diritti non è un rischio, ma è la realtà di oggi, e l’attuale sistema, per la sua intrinseca inefficienza, è destinato a generare squilibri sociali e territoriali sempre più marcati. Per questo, credo che anche il sindacato si debba riposizionare, e debba riesaminare tutta la propria strumentazione, aprendo una ricerca impegnativa sulle implicazioni che il federalismo comporta sulle forme organizzative e contrattuali e sul sistema delle relazioni sindacali.
Cominciare a discutere di questi problemi sarebbe già un primo risultato. Per questa via si può avviare anche la formazione di gruppi dirigenti locali che siano capaci di autonomia, capaci di assumersi la responsabilità della decisione politica, senza dover attendere qualche autorizzazione che deve venire dall’alto. Il centralismo ha sempre questo effetto di mortificare le risorse di creatività e di responsabilità, e quando un’organizzazione dipende da un solo centro di comando e non sa costruire un sistema forte di autonomie, essa ha una fragilità strutturale, perché non c’è classe dirigente diffusa e non c’è radicamento nel territorio.
Questa fragilità non può essere compensata dall’autorevolezza della leadership, e di fronte al primo duro impatto con la realtà si può determinare uno stato incontrollabile di crisi e di sbandamento. Mi sembra che sia esattamente questa oggi la situazione del sindacato. Per questo il federalismo, ovvero l’articolazione dei poteri e delle sedi decisionali, è una necessità anche per il sindacato: non è il rischio della disarticolazione, ma al contrario è la costruzione di una struttura più solida e più aderente alla realtà, in grado quindi di affrontare le difficili sfide del presente.
La “concertazione” territoriale
La dinamica dei processi istituzionali, che abbiamo fin qui esaminato, chiama in causa l’urgenza di una riforma del sindacato, di una sua ricollocazione strategica. Piena assunzione di una responsabilità politico-istituzionale, trasparenza dei processi democratici, scelta federalista coerente e costruzione di sistemi di autogoverno locale: sono queste le fondamentali linee direttive che debbono guidare il progetto di riforma del sindacato.
Ma i termini del problema risultano ancora più chiari e stringenti se prendiamo in considerazione le dinamiche sociali, i mutamenti che sono intervenuti nei sistemi di produzione e nella struttura sociale, i quali segnano una netta cesura rispetto al passato, un vero e proprio passaggio di fase, con l’esaurimento del paradigma fordista e con l’apertura verso un futuro ancora incerto nei suoi sbocchi, indeterminato nelle sue dinamiche di fondo, ma tale comunque da richiedere categorie di interpretazione e strumenti di regolazione politica del tutto nuovi rispetto a tutta l’esperienza, politica e sindacale, fin qui conosciuta.
Dove sta il punto di rottura? Sta anzitutto nel fatto che stiamo passando da un capitalismo di fabbrica ad un capitalismo di sistema, in quanto ciò che oggi è strategicamente decisivo è l’organizzazione complessiva dei fattori sociali e ambientali, e la competizione non è più essenzialmente una competizione di imprese, ma una competizione di sistemi. La tendenza verso un’organizzazione globale della società secondo criteri di competitività determina nuove contraddizioni, le quali non stanno più nel tradizionale luogo di produzione, ma nel sistema sociale. Il capitalismo, in questo passaggio dalla fabbrica al sistema sociale, riproduce su una scala assai più ampia contraddizioni e disuguaglianze, e ha un effetto di lacerazione del tessuto sociale, in quanto è tutta l’organizzazione della società che si rimodella sui parametri di efficienza e di competitività, invadendo tutte le sfere di autonomia, destrutturando tutti gli elementi di socialità e di coesione comunitaria, determinando così un vero e proprio mutamento antropologico ed esistenziale nelle condizioni di vita delle persone. Il capitalismo tende a rompere gli argini, a distruggere tutto il sistema delle tutele e delle protezioni sociali, e pretende che l’intera vita sociale sia guidata esclusivamente dalla logica del mercato.
Salta quindi l’equilibrio che si era costruito tra Stato e mercato, tra democrazia e capitalismo, e gli stessi spazi della politica vengono messi in discussione, in quanto le decisioni sono vincolate, obbligate, e conta solo la forza espansiva del mercato mondiale. La stessa democrazia viene svuotata, perché i luoghi della decisione non sono più luoghi politici, e quindi controllabili e aperti ad una pluralità di opzioni possibili, ma la decisione stessa è precostituita, perché sopra ogni altra cosa valgono le esigenze oggettive dell’economia competitiva e mondializzata.
In queste nuove condizioni, il problema centrale non è più il conflitto di fabbrica, ma il conflitto sociale. La tradizionale contraddizione di classe si allarga e investe le forme della convivenza sociale. Il sindacato, allora, che ha costruito storicamente la sua forza nella grande fabbrica fordista, rischia oggi di essere completamente spiazzato, e rischia di divenire un elemento di conservazione, di difesa corporativa dell’area di lavoro protetta, senza svolgere nessuna funzione davvero incisiva sugli equilibri sociali complessivi, sui fenomeni di esclusione, di marginalizzazione, di precarizzazione, i quali mettono in discussione i diritti fondamentali di cittadinanza e mutano in profondità la morfologia sociale e lo stesso sistema di valori a cui essa fa riferimento.
D’altra parte, il mondo del lavoro si differenzia, si articola in forme nuove, e la figura classica del lavoratore dipendente a tempo indeterminato non è più, come è stato nel passato, la regola, la figura dominante, e quindi il punto di riferimento privilegiato dell’azione sindacale, ma al contrario si afferma una proliferazione e un’articolazione di diverse figure sociali, e diviene del tutto aleatorio lo stesso confine tra lavoro dipendente e lavoro autonomo.
Il sindacato ha il problema di rappresentare la nuova realtà del lavoro e la nuova realtà sociale: gli esclusi, i precari, e anche le nuove figure che stanno al confine tra lavoro dipendente e lavoro autonomo e che si trovano oggi nella condizione di doversi difendere individualmente, senza garanzie e senza rappresentanza, in un contesto di competitività senza regole. Tutto ciò comporta una ridefinizione del ruolo del sindacato, un cambiamento anche sotto il profilo teorico, in quanto non si tratta più solo di organizzare “la classe” del lavoro dipendente nel suo conflitto con il capitale, ma di costruire strumenti di tutela, di organizzazione, di solidarietà, in una prospettiva sociale più larga, pensando e operando in termini di società e non solo di impresa, di diritti del cittadino e non solo del lavoratore.
Credo che sia ormai matura la necessità di una nuova definizione dell’organizzazione sindacale, superando il riferimento esclusivo al lavoro dipendente, per aprirsi a tutta la vasta costellazione di figure sociali deboli che hanno la necessità di strumenti di protezione e di tutela. D’altronde è già avvenuto così con l’organizzazione sindacale dei pensionati e degli anziani, la quale si occupa, appunto, non di un rapporto di lavoro, ma di una condizione sociale, di uno specifico universo sociale visto nelle sue condizioni materiali ed esistenziali, e la forza espansiva che ha caratterizzato il sindacato dei pensionati dimostra come ci possa essere un vasto campo di iniziativa e di organizzazione ancora inesplorato.
In questo senso il sindacato diviene un attore politico, perché non si occupa solo, in termini corporativi, di un segmento sociale delimitato, ma si pone il problema dell’organizzazione sociale nel suo insieme, del progetto di società. Il problema centrale oggi, di fronte ad un capitalismo pervasivo e alla tendenza ad organizzare la società come dominio esclusivo dei meccanismi competitivi, è la ricostruzione degli spazi di socialità.
È la socialità la risorsa scarsa, e questo deficit di socialità determina tensioni, egoismi, rancori, per cui l’intero contesto sociale diviene il terreno di una competizione, di un conflitto di interessi, di una contrapposizione violenta tra i diversi gruppi sociali. In queste condizioni il paese rischia di essere ingovernabile, di essere così profondamente lacerato da non poter costruire nessun progetto politico per il futuro.
È quello che oggi sta accadendo, con il prevalere di politiche “corporative”, che alimentano la mobilitazione degli interessi di parte contro ogni tentativo di costruzione del bene comune. In questo difficile passaggio, il paese ha invece bisogno di una più forte solidarietà, di una convergenza sugli obiettivi di fondo.
Se il sindacato risponde a questa domanda di socialità e di coesione nazionale, esso può divenire il punto di riferimento per un’area assai larga di forze e di gruppi sociali e può svolgere una funzione politica rilevante; se viceversa si limita al suo mestiere “tradizionale”, esso sarà solo uno dei soggetti che sta sul mercato e che subisce la logica del mercato, senza nessuna capacità di prospettare soluzioni che guardano al di là degli equilibri di potere consolidati, e senza nessuna forza di attrazione per quella grande galassia che è costituita dagli esclusi, dai non garantiti, e da tutti coloro che sono gettati nel meccanismo competitivo e che non hanno strumenti di tutela, di rappresentanza, di sostegno.
Ecco che allora ritroviamo le ragioni di fondo di un sindacato “politico”, perché appunto si occupa della dinamica sociale complessiva, dei suoi elementi di coesione, si occupa quindi necessariamente di scelte e di decisioni di carattere politico. E, nello stesso tempo, torna il tema del federalismo e dell’autogoverno, perché è essenzialmente nella dimensione territoriale, nell’autonomia e nella diversità dei sistemi locali, che possono trovare una risposta e una sintesi le domande sociali.
Il radicamento nel territorio è l’unico modo per non essere travolti, per non subire passivamente gli effetti della mondializzazione, e per tentare delle risposte, delle soluzioni, cercando di costruire una coalizione di forze, di soggetti diversi, che insieme definiscano le risposte da dare ai nuovi bisogni di socialità, di promozione sociale, di identità collettiva, di organizzazione dello spazio pubblico.
La “concertazione” territoriale è la risorsa strategica da attivare, e sta proprio qui il campo di lavoro finora ancora poco esplorato. È questo, tra l’altro, l’unico modo efficace, non retorico, non propagandistico, di rispondere alle proposte secessioniste della Lega, in quanto si costruisce una rete territoriale che funziona, che risponde ai bisogni reali.
Lungo questa traiettoria il sindacato si incontra con altri soggetti, con il complesso delle organizzazioni sociali che si trovano ad essere impegnate sul medesimo terreno: associazioni del volontariato, cooperazione, impresa sociale. Un più stretto raccordo e forme nuove di collaborazione e di integrazione tra il sindacato e questi soggetti possono essere utili e possono aprire nuove prospettive.
La CISL si sta muovendo in questa direzione e sarà questa, sembra, una delle scelte qualificanti del prossimo congresso, ma il fatto che un tema di così grande importanza sia affrontato da una sola organizzazione sindacale, che esso sia usato come elemento che caratterizza un’identità di parte, tutto ciò determina il rischio di una definitiva divaricazione tra le confederazioni sindacali, ciascuna delle quali cerca da sola la soluzione ai problemi strategici del momento, e finisce per accentuare gli elementi di identità separata, di proiezione ideologica, rendendo così del tutto impraticabile il cammino dell’unità sindacale. L’iniziativa della CISL, che tocca una questione sicuramente importante, finisce per essere negativa e controproducente se viene giocata in una logica esclusiva di organizzazione, perché essa assume inevitabilmente un carattere ambiguo e appare non come un’apertura del sindacato verso nuove frontiere, ma come il ripiegamento dentro una vecchia impostazione di natura ideologica e confessionale, per la costruzione di un grande centro sociale cattolico che si presenta come alternativa al progetto dell’unità sindacale.
È un esempio illuminante, il quale dimostra come qualsiasi scelta finisce per essere sbagliata se non si colloca dentro il disegno unitario. Senza unità sindacale, ci saranno solo tentativi parziali, spezzoni di risposta, viziati e compromessi in partenza proprio per l’assenza del respiro unitario che è oggi indispensabile. Pensare l’unità significa pensare alle domande strategiche di fondo a cui il movimento sindacale deve dare una risposta, mentre, se si ragiona in termini di organizzazione, si costruiscono identità parziali e unilaterali, e si smarrisce il senso di una ricerca che abbia davvero il respiro strategico necessario.
L’unità può essere l’apertura di una nuova fase. Viceversa, il mantenimento delle vecchie logiche di organizzazione comporta necessariamente la sopravvivenza di tutti gli elementi di debolezza perché ciascuno si pone solo il problema di legittimare se stesso, e quindi ragiona in un ambito ristretto, in una dimensione solo parziale. E tutto finisce per essere strumentalizzato, piegato ai bisogni artificiali di competizione, di difesa dell’identità, di orgoglio di organizzazione.
È un vicolo cieco, che non porta da nessuna parte, perché ripropone le ragioni del passato nel momento stesso in cui queste ragioni sono definitivamente tramontate. L’obiettivo dell’unità sindacale è quindi il terreno obbligato, è l’unico terreno vitale sul quale si può impostare una nuova strategia di rilancio delle ragioni del sindacato.
Verso l’unità sindacale
La prospettiva dell’unità sindacale, della costruzione di un nuovo soggetto sindacale unitario, sembrava essere fino a poco tempo fa a portata di mano, ma ora il quadro si è rapidamente deteriorato, e ciascuna organizzazione sembra puntare solo al proprio rafforzamento, a vincere la competizione in un contesto di pluralismo sindacale destinato a restare, ancora per lungo tempo, come un dato strutturale della situazione italiana.
Ma si tratta di una competizione senza vincitori, perché il risultato è solo l’indebolimento complessivo dell’intero movimento sindacale. Un sindacato diviso, questa è mia ferma convinzione, non ha la forza per vincere la partita strategica che oggi è aperta. La divisione prepara la sconfitta.
Negli attuali gruppi dirigenti del sindacalismo confederale prevale, evidentemente, una diversa valutazione, in base alla quale è possibile, ancora per un periodo di tempo non breve, continuare con una pratica di unità di azione tra organizzazioni che restano distinte, divise nella loro identità e nella loro cultura.
Secondo questa impostazione, dell’unità si può continuare a discutere, ma non c’è nessuna urgenza, nessuna precipitazione della crisi che ci costringe a bruciare i tempi, e non è un dramma se questa discussione richiederà ancora molti anni di confronto, di polemica, di ricerca. Oggi le condizioni non ci sono: prendiamoci quindi tutto il tempo che è necessario.
Si tratta, a mio giudizio, di un errore di prospettiva storica, di un deficit di lungimiranza strategica, che può provocare dei pericolosi processi involutivi. Non si comprende come i processi politici abbiano i loro ritmi, i loro tempi obbligati, per cui ciò che giunge oggi a maturazione non può essere rinviato a un domani immaginario.
Oggi l’unità è difficile, ma possibile. È possibile proprio perché è l’intero quadro politico che si viene riorganizzando, e in una situazione, come quella attuale, aperta a fluida, c’è lo spazio per una iniziativa nuova e creativa. Domani è probabile che questo spazio si richiuda, perché le differenze torneranno a cristallizzarsi, e le diverse identità si ricomporranno. Prendere tempo significa, nei fatti, affossare il progetto di unità, perché il tempo a disposizione si sta esaurendo.
Probabilmente non si tratta di una scelta consapevole, ma solo di un atto di prudenza tattica. Ma intanto viene trasmesso un segnale di rinuncia, e si determinano nuovi elementi di diffidenza e di sfiducia, per cui le condizioni nel prossimo futuro saranno sempre meno favorevoli.
Perché ci troviamo oggi in questa situazione di stallo? Credo che stiamo pagando gli effetti negativi di un eccesso di “realismo”, di pragmatismo, il quale consiste nel saper vedere solo i problemi dell’oggi e non quelli del futuro. Ma di realismo si muore. Esso resta chiuso nell’orizzonte delle situazioni di fatto, dei rapporti di forza consolidati, e non sa immaginare una iniziativa che sia capace di forzare la situazione. È il contrario della virtù politica, che è capacità di trascendere l’esistente, di rompere il cerchio della realtà fattuale, di irrompere nella realtà con una iniziativa progettuale che sposta in avanti tutti i dati della situazione.
L’unità sindacale può essere solo un atto politico creativo, e non un atto di realismo. Essa è una operazione complessa e rischiosa: ci saranno sempre infinite ragioni che consiglieranno ai realisti di prendere tempo, e di fare intanto quelle poche e limitate cose che è possibile fare subito. Io credo all’opposto che il compito più urgente per il sindacato sia la costruzione del suo futuro. In assenza di un progetto aperto sul futuro, di una prospettiva, di una strategia, vengono meno le motivazioni, le “ragioni forti” dell’agire sindacale, e si innesca quindi un processo di declino.
Discutere dell’unità sindacale vuol dire appunto discutere del futuro. Vuol dire guardare al di là delle contingenze immediate, delle ragioni tattiche, e interrogarsi sulle ragioni di fondo del sindacato nel prossimo futuro che si viene organizzando. Ciò significa contemporaneamente due cose: che l’unità è la prospettiva necessaria di un movimento sindacale che non sia prigioniero del passato, e che essa si costruisce nel vivo di una riflessione strategica che affronta i nodi oggi essenziali.
Non basta l’appello retorico all’unità, se non c’è contestualmente l’indicazione chiara di un cammino in vista del quale riorganizzare le forze, le motivazioni, le energie potenziali che oggi appaiono bloccate. Senza unità non c’è strategia vincente, e senza strategia non c’è un progetto unitario capace di forza espansiva: i due aspetti sono tra loro strettamente connessi.
Per questo, è essenziale una discussione di massa e una mobilitazione la più larga possibile, perché appunto non si tratta solo di mettere insieme quello che c’è, ma di creare qualcosa di nuovo. Un’operazione solo di vertice non può funzionare, perché essa non avrebbe quella portata innovativa che è necessaria, e perché è proprio nei vertici burocratici del sindacato che stanno le resistenze e gli ostacoli che impediscono il progetto unitario.
Occorre un lavoro di base: riprogettare il sindacato a partire dalle nuove rappresentanze unitarie nei luoghi di lavoro e dalle strutture territoriali di base, dando loro spazio e respiro politico, e mettendo a punto un progetto che pensa l’unità come riorganizzazione democratica, come sburocratizzazione, come costruzione di un movimento che si forma nelle nuove contraddizioni sociali del presente.
L’unità è la grande occasione per la riforma del sindacato. Nei luoghi di lavoro e nel territorio si può cominciare a mettere mano a questo lavoro di riforma, mettendo in moto energie nuove che siano capaci di spezzare le barriere burocratiche.
Forse siamo ancora in tempo.
Busta: 41
Estremi cronologici: 1997
Autore: AA. VV.
Descrizione fisica: Volume, b/n, 108 pp.
Tipo: Scritti
Serie: Scritti Sindacali - CGIL -
Note: 2 voll. Con bozza
Pubblicazione: Ediesse, Roma, 1997, pp. 91-108

